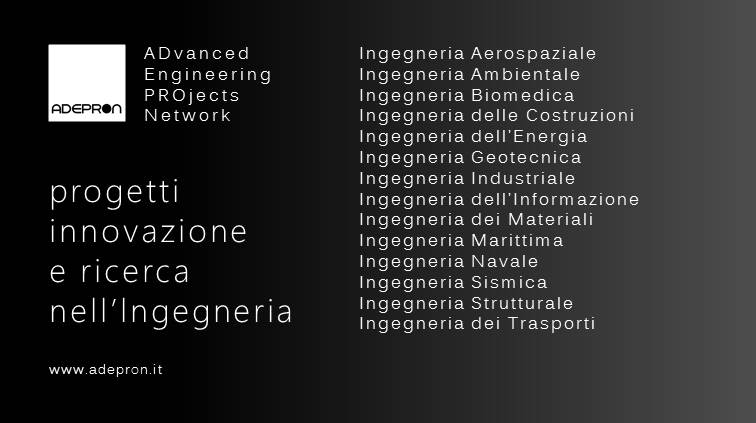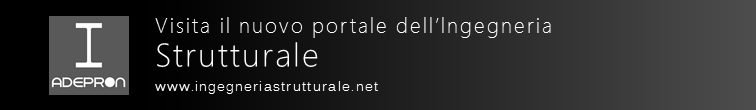|
· · Meccanica delle Strutture · Strutture in Calcestruzzo Armato · · COMPORTAMENTO E RESISTENZA STRUTTURALE ALL’INCENDIO · Marco Bozza · · INTRODUZIONE · Durata
di resistenza all'incendio · LivellI
di danneggiamento della struttura · CRITERI DI VERIFICA DELLA SICUREZZA
STRUTTURALE
· · · ·
·
· INTRODUZIONE
Il materiale strutturale e l'incendio
L'analisi delle problematiche generali di strutture soggette ad un possibile incendio è di fondamentale importanza per una corretta progettazione strutturale, al fine di garantire un adeguato margine di sicurezza alla resistenza strutturale, tale da consentire l'incolumità delle persone che vi si trovano al loro interno. Il comportamento delle strutture delle costruzioni,
civili e industriali, all'azione di un incendio è innanzi tutto condizionato
dal materiale di cui la struttura è costituita. Nel caso specifico, il
cemento armato, come materiale composito, ha un comportamento simbiotico: il
calcestruzzo protegge, con la sua ridotta conducibilità termica, l'acciaio,
che gli fornisce la capacità di resistere a trazione, isolandolo dai gas
caldi dell'incendio e ritardandone così la perdita di resistenza. La risposta
all'incendio di una struttura di cemento armato è sostanzialmente positiva,
ma la varietà e variabilità dei fenomeni connessi con lo sviluppo
dell'incendio e con il comportamento del calcestruzzo soggetto a forti
gradienti termici (shock termico), rende alquanto complesso il tentativo di
determinare quantitativamente la risposta strutturale. Per dare un
inquadramento alla problematica è necessario svolgere un esame più
dettagliato dei principali aspetti coinvolti: - l'incendio come "azione" sulla struttura; - il comportamento del materiale di cui la struttura è
costituita; - il comportamento della struttura nel suo complesso; - il livello di capacità di prestazione richiesto alla
struttura. L'azione incendio
L'incendio agisce sulla struttura in quanto ne riscalda
gli elementi, provocando dilatazioni, coazioni, e degrado dei materiali.
Essendo la temperatura il parametro principale che governa la risposta dei
materiali, l'azione incendio viene pertanto descritta attraverso l'evoluzione
nel tempo della temperatura dei gas caldi, prodotti dalla combustione, che
entrano in contatto con la struttura, trasmettendole calore per convezione ed
irraggiamento. Le modalità di evoluzione di un incendio sono le più varie e
dipendono da innumerevoli fattori: in generale può essere individuata una
prima fase di innesco con temperature crescenti, ma ancora non molto elevate.
Alla fase di innesco segue un'estensione rapida ed incontrollata della
combustione, tale da renderla irreversibile e generalizzata. E' questa la
condizione di FLASH-OVER, oltre la quale inizia la fase di sviluppo pieno
dell'incendio, producendo un notevole innalzamento della temperatura fino ad
un massimo, quando inizia ad esaurirsi il materiale combustibile. Segue la
fase di spegnimento, con una riduzione progressiva e lenta della temperatura. Trascurando
le cause dell'innesco, i parametri che influiscono sullo sviluppo
dell'incendio sono principalmente la natura e quantità dei materiali
combustibili, le modalità di apporto del comburente (ossigeno), la presenza
di provvedimenti atti a circoscrivere spazialmente i fenomeni
(compartimentazione) o ad ostacolarne lo sviluppo (impianti di spegnimento
automatico). Durata di resistenza
all'incendio
Quando in una costruzione si sviluppa un incendio, dal
punto di vista della sicurezza la prima preoccupazione è relativa
all'incolumità delle persone che si trovano nei locali coinvolti
nell'incendio ed in quelli limitrofi, nonché dell'incolumità dei
soccorritori. Questi ultimi, anche se adeguatamente protetti dalle fiamme e
dai fumi, devono contare sulla capacità di resistenza delle strutture per
poter intervenire nei locali investiti dall'incendio. E' quindi fondamentale
che sotto l'azione di un incendio abbastanza gravoso. Le strutture abbiano
una sufficiente capacità di resistenza in termini di "durata", in
modo tale da consentire l'intervento delle squadre di soccorso all'interno
delle costruzioni con adeguata sicurezza. A tale fine sono state stabilite
delle opportune curve temperatura-tempo convenzionali, rappresentative delle
condizioni più gravose di incendio, in rapporto alle quali stabilire la
capacità di un elemento, strutturale o non strutturale, a fornire l'adeguata
risposta in termini di resistenza (R), tenuta (E) ed isolamento (I). Queste curve, rappresentando azioni sempre crescenti e
di durata illimitata, sono concepite per portare comunque alla crisi di una
struttura, determinando così una "durata di resistenza"
all'incendio intesa come intervallo di tempo che intercorre dallo sviluppo
dell'incendio (punto di flash-over) alla crisi della struttura. La resistenza di una struttura all'incendio viene
quindi espressa in termini di "minuti" e le strutture classificate
secondo la durata di resistenza in classi R30, R60, R90, R120, R150, R180,
R210, R240 minuti a seconda delle esigenze di protezione, del carico di
incendio, dei provvedimenti di prevenzione e protezione esistenti. LivellI di
danneggiamento della struttura
Nella maggior parte dei casi l'incendio non
porta a distruzione la struttura, ma ne provoca soltanto un danneggiamento.
Il problema che si pone è quello di valutare il livello di danneggiamento
subito dalle strutture per arrivare a stabilire il grado di sicurezza residuo
e, nel caso questo sia giudicato insufficiente, prevedere i provvedimenti di
rinforzo e ripristino necessari. La tendenza attuale nell'Ingegneria
Strutturale, su questo problema, è quella di prevedere per una struttura, non
solo la durata di resistenza, come prima definita, ma anche il livello di
danneggiamento in caso di incendio reale, allo scopo di garantire un
opportuno "livello di protezione" PBD (Performance Based Design),
in funzione della destinazione di impiego della struttura stessa. Per le strutture soggette ad incendio si prevedono
cinque differenti livelli di protezione: - Livello I
nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze
del crollo delle strutture siano accettabili o dove il rischio di incendio
sia trascurabile; - Livello II
requisiti di resistenza al fuoco delle strutture per un periodo
sufficiente a garantire l'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro e
l'intervento delle squadre di soccorso; - Livello
III requisiti di resistenza al fuoco
delle strutture tali da evitare, per tutta la durata dell'incendio, il
collasso delle strutture stesse; - Livello
IV requisiti di resistenza al fuoco
delle strutture per garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato
danneggiamento delle strutture stesse; - Livello V
requisiti di resistenza al fuoco delle strutture per garantire, dopo la fine
dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità delle strutture
stesse. La
capacità portante dovrà essere mantenuta per tutto il tempo necessario a
garantire le prestazioni associate a ciascun livello. Il secondo livello corrisponde
a quanto già previsto dalle normative attuali con la relativa classe di
resistenza REI. I livelli superiori prevedono che la struttura non collassi e
subisca danni progressivamente meno importanti. Per garantire il Livello IV si richiede che le
costruzioni debbano essere oggetto delle seguenti verifiche: - controllo della capacità portante per tutta la durata
dell'incendio; - controllo del regime deformativo entro limiti
accettabili; - mantenimento di una capacità portante residua che
consenta interventi di ripristino. Per garantire il Livello V si richiede che le
costruzioni debbano essere oggetto delle seguenti verifiche: - controllo della capacità portante per tutta la durata
dell'incendio; - regime deformativo trascurabile; - mantenimento di una capacità portante residua
adeguata alla destinazione di progetto. CRITERI DI VERIFICA DELLA SICUREZZA STRUTTURALE
Stabiliti
i requisiti prestazionali richiesti, sono necessari i criteri in base ai
quali poter stabilire se il grado di sicurezza richiesto è effettivamente
conseguito dalla struttura o dall'elemento strutturale in esame. Attualmente
la verifica della sicurezza viene affidata solo all'analisi dei singoli
elementi strutturali considerati isolati: si ammette implicitamente che la
sicurezza all'interno del sistema strutturale sia garantita dalla sicurezza
dei singoli componenti. Per conseguire tale scopo la normativa consente
l'utilizzo di tre diverse metodologie di progetto: sperimentale, tabellare,
analitica. Metodologia
di progetto sperimentale
Attualmente ammessa sia dalla normativa nazionale, che
da quella europea, la metodologia sperimentale si basa sulle seguenti
ipotesi: - la resistenza al fuoco del sistema strutturale è
garantita qualora sia verificata la resistenza al fuoco di tutti gli elementi
strutturali presi individualmente; - la resistenza al fuoco dei singoli elementi
strutturali è verificata attraverso prove standard in camera d'incendio. Sia le dimensioni geometriche che lo stato di tensione applicato
devono essere confrontabili con quelli relativi all'impiego finale
nell'edificio. A tale fine sono prescritte le dimensioni minime degli
elementi di prova ed i carichi applicati durante la prova stessa: in
particolare sono prescritti i carichi che generano il raggiungimento dello
stato di tensione ammissibile nel punto più sollecitato. La metodologia di
progetto sperimentale è completata da un insieme di regole prescrittive,
elaborate su base empirica dalla valutazione dei risultati delle prove. I vantaggi di questa procedura sono: - avere a disposizione una metodologia di progettazione
utilizzata con successo per molti anni; - avere a disposizione una vasta letteratura
internazionale per l'interpretazione dei risultati. Gli svantaggi sono costituiti da: - costi alti delle prove sperimentali; - limiti nelle dimensioni geometriche massime
dell'elemento di prova, dattati dalle dimensioni dei forni; - possibilità di riprodurre leggi di riscaldamento
temperatura-tempo monotone crescenti; - difficoltà nella riproduzione delle effettive
condizioni di vincolo dell'elemento strutturale in esame. Metodologia
di progetto tabellare
La
metodologia di progetto "tabellare" è ammessa dalle normative
internazionali quando la resistenza al fuoco richiesta, le caratteristiche
geometriche della sezione resistente, gli spessori minimi del copriferro ed i
quantitativi minimi di armatura degli elementi strutturali in esame rientrano
in determinati limiti. Se l'elemento strutturale in esame soddisfa i
requisiti sopracitati, allora non sono necessarie ulteriori verifiche della
resistenza al fuoco. Il metodo è recepito dalla normativa UNI 9502 e da
quella europea tramite l'Eurocodice 2, Parte 1-2. Metodologia
di progetto analitica
La
relazione fondamentale della verifica analitica della sicurezza per le
strutture soggette ad incendio è l'espressione:
(capacità di prestazione di calcolo della sezione ³ richiesta della prestazione), dove, in generale,
i due membri possono essere esplicitati in funzione di: - resistenza temporale al fuoco:
- effetto
delle azioni:
-
temperatura:
con: tfi,d = valore di progetto della resistenza
al fuoco; tfi,requ = valore richiesto della resistenza
al fuoco; Rfi,d,t = valore di progetto della
resistenza in caso di incendio; Efi,req,t = valore di progetto dell'effetto
delle azioni nella situazione d'incendio; Qcr,d = valore di progetto della temperatura critica; Qd = valore di progetto della temperatura del materiale Vantaggi e svantaggi
del metodo analitico
I vantaggi della metodologia di progetto analitica sono
dati da: - costi contenuti; - possibilità di analisi di interi sistemi strutturali; - possibilità di applicazione di leggi di riscaldamento
temperatura-tempo diverse dalla monotonia; - nessun limite alle dimensioni geometriche degli
elementi. Gli svantaggi sono invece costituiti dall'attuale
incapacità di una corretta modellazione matematica dei seguenti fenomeni: - perdita di tenuta al fumo, ai gas caldi ed alle
fiamme; - danneggiamento localizzato del calcestruzzo
("spalling"); - meccanismi di rottura innescati dalle sollecitazioni
taglianti e torcenti; - collasso per insufficiente capacità rotazionale
(duttilità); - instabilità localizzata delle armature compresse; - perdita dell'aderenza; - danneggiamento dei dispositivi di ancoraggio. Va, però, evidenziato che attualmente potenti codici di
calcolo permettono la modellazione strutturale ad elementi finiti con
complesse condizioni al contorno, tenendo in considerazione sofisticate leggi
di riscaldamento e trasferimento di calore agli elementi strutturali. Ciò
consente di eseguire complesse analisi termiche temporali, considerando
l'aumento progressivo del danno strutturale per effetto del calore. Tuttavia,
tali procedure, oltre a richiedere un alto livello di competenze
nell'utilizzo dei codici stessi, risultano poco agevoli in termini di
praticità e tempo di esecuzione. Nonostante questi limiti, i vantaggi della metodologia analitica, rispetto a quella sperimentale, risultano evidenti in termini di rapporto costi/benefici. |
||||||||||||||||||||||
|
ingegneriastrutturale.net -
Tutti i Diritti Riservati |