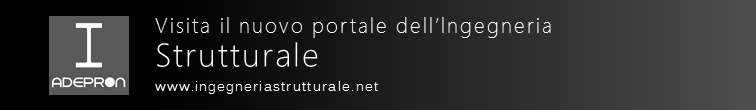|
· · Meccanica delle Strutture · Strutture in Calcestruzzo Armato · · CALCESTRUZZI STRUTTURALI AD ALTA RESISTENZA · Marco Bozza · · INTRODUZIONE · COMPORTAMENTO MECCANICO · PROPRIETÁ
MECCANICHE · Modulo
elastico · Coefficiente di contrazione trasversale · COMPORTAMENTO
A FATICA · Calcestruzzo
armato · ·
· Introduzione
I calcestruzzi vengono suddivisi in 3 categorie, a
seconda del rapporto acqua/cemento
(a/c) e della loro resistenza caratteristica cubica Rck: · CALCESTRUZZO A RESISTENZA NORMALE (NR): conglomerato
cementizio caratterizzato in generale da a/c > 0,45 e con Rck
£ 55 N/mm2; · CALCESTRUZZO AD ALTE PRESTAZIONI (AP): conglomerato
cementizio caratterizzato in generale da a/c < 0,45 e con 55 < Rck £ 75 N/mm2; · CALCESTRUZZO AD ALTA RESISTENZA (AR): conglomerato
cementizio caratteizzato in generale da a/c < 0,35 e con 75 < Rck £ 115 N/mm2; Generalità sui calcestruzzi AR
I calcestruzzi AR sono ottenuti utilizzando i materiali
ordinari e la tecnologia convenzionale di produzione, di posa in opera e di
stagionatura. I calcestruzzi AR sono caratterizzati da basso rapporto in peso
acqua/legante (a/l), da alto dosaggio di legante, dall'impiego di aggiunte
minerali (materiali inorganici idraulicamente attivi (loppa granulata
d'altoforno) o reattivo verso l'idrossido di calcio (ceneri volanti, argille
calcinate, pozzolane naturali, microsilice, silice
precipitata), che intervengono sulle caratteristiche fisico-meccaniche e
sulla durabilità del calcestruzzo) e di additivi chimici superfluidificanti,
spesso dombinati con ritardanti. Il dosaggio del
legante varia nell'intervallo 400 ¸ 550 Kg/m3 e rappresenta il
totale del cemento Portland più le aggiunte minerali attive. Il rapporto a/l
è generalmente nell'intervallo 0,25 ¸ 0,35 ma sono stati prodotti impasti con
rapporto inferiore a 0,25; spesso al rapporto a/l si abbina quello fra acqua
e cemento Portland, a/c. Affinché ai bassi valori del rapporto a/l il legante possa
essere omogeneamente disperso nell'impasto, è indispensabile l'uso di un
efficace superfluidificante. I materiali e i
rapporti di composizione per il calcestruzzo AR sono scelti sulla base di
prove di laboratorio. Lo studio degli impasti di prova per la determinazione
dei rapporti ottimali richiede lavoro sperimentale. Nella scelta dei
materiali localmente disponibili (cemento, aggregato, aggiunte minerali,
additivi) l'obiettivo è la ricerca dei componenti che manifestino il massimo
di compatibilità. Tale compatibilità può essere valutata (a) attraverso la
«resa» di resistenza meccanica a compressione (cioè la resistenza per unità
di peso di cemento, o di legante, ad una assegnata stagionatura), e/o (b) in
termini di slump, e di mantenimento di un dato livello di slump per un
prefissato periodo di tempo. Individuati i materiali ed i rapporti ottimali di
composizione, occorre accertare che i risultati di laboratorio possano essere
riprodotti nella particolare situazione di cantiere, e soltanto dopo che tutte
le procedure siano state definite si compila il dettaglio del piano di
assicurazione della qualità. A differenza di quanto avviene per il
calcestruzzo NR, è stato constatato che per ottenere una soddisfacente
riproducibilità è necessario che nella prove di resistenza a compressione le
tolleranza relative alle dimensioni dei provini siano più strette, e che
nelle prove di resistenza a flessione i provini siano umidificati fino alla
conclusione della prova. COMPORTAMENTO MECCANICO
Il comportamento meccanico del calcestruzzo AR è per
alcuni aspetti differente da quello del calcestruzzo normale. Le differenze
hanno origine dalla notevole diversità delle loro microstrutture. Perciò le
proprietà meccaniche del calcestruzzo AR non possono essere dedotte per
estrapolazione da quelle del calcestruzzo normale, né è corretto applicare
tout-court le relazioni tra la resistenza a compressione e le altre proprietà
meccaniche, così come sono state sviluppate per i calcestruzzi normali. Nel calcestruzzo di elevato rapporto a/c la
microstruttura della matrice legante è caratterizzata da una elevata porosità
capillare e dalla presenza di una zona d'interfaccia con l'aggregato grosso
(spessore medio 50 mm), che differisce dalla matrice indisturbata (lontana
dall'aggregato) per composizione, morfologia densità. La zona d'interfaccia,
detta anche zona di transizione, si distingue per la maggiore
dimensione media dei pori e per la presenza, nella fascia contigua
all'aggregato, di cristalli - orientati e ben sviluppati - di idrossido di
calcio (portlandite) e di bastoncini di trisolfoalluminato idrato (ettringite).
A causa della notevole difettosità della zona di
transizione vi è poco trasferimento di carico tra matrice legante e
aggregato, e di conseguenza le proprietà dell'aggregato non influiscono in
modo significativo su quelle della matrice legante. Quest'ultima rappresenta
l'anello debole del sistema e quindi da sola caratterizza il comportamento
meccanico del materiale. Pertanto il calcestruzzo normale può essere visto
come un materiale, costituito da inclusioni molto rigide e resistenti
(aggregato) e da una matrice assai deformabile e porosa (la malta
cementizia). Esercitando tuttavia l'aggregato un effetto di contenimento
quasi isotropo sulla malta (almeno in compressione), si può dire che a
livello macroscopico il comportamento del calcestruzzo sia assimilabile a
quello di un materiale elastico-lineare-omogeneo-isotropo (per stati
tensionali e deformativi abbastanza bassi), in cui tutte le proprietà
meccaniche (ad esempio modulo elastico e resistenza a trazione) dipendono
dalla resistenza a compressione, attraverso leggi semplici. A maggior regione può essere considerato
elastico-lineare-omogeneo-isotropo il calcestruzzo AR, in cui - grazie alle
ottime qualità della malta cementizia (compatta, rigida, resistente) - non vi
sono rilevanti differenze di proprietà meccaniche fra malta e aggregato, al
punto che il comportamento elastico-lineare in compressione si mantiene anche
per stati tensionali e deformativi piuttosto alti (fin quasi alla soglia
della resistenza in compressione). Il trasferimento di carico fra matrice e
aggregato grosso è facilitato dalla minore difettosità ed estensione della
zona di transizione, la quale tende addirittura a scomparire, quando parte
del cemento è sostituita da fumo di silice. Mentre le proprietà del calcestruzzo normale sono
influenzate solo da quelle della malta, nel calcestruzzo AR giocano ruoli
importanti sia la malta sia l'aggregato: la resistenza a compressione aumenta
al diminuire del rapporto a/c fino a quando la resistenza allo schiacciamento
dell'aggregato non diventi l'anello debole del sistema. A questo punto, per
aumentare ulteriormente la resistenza a compressione attraverso la
diminuzione del rapporto a/c, occorre cambiare aggregato ed usarne uno più
resistente. A tal proposito si può dire che per impasti con
rapporti a/c uguali a 0,6 e a 0,3, le differenze microstrutturali sono nette;
nell'intervallo da PROPRIETÁ MECCANICHE
Come nel caso del calcestruzzo normale, le proprietà
meccaniche fondamentali sono: la resistenza a compressione fc, la resistenza a trazione fct, il modulo elastico Ec
e il coefficiente di contrazione trasversale nc. Resistenza
a compressione
I calcestruzzi sono classificati e designati in base
alla resistenza caratteristica a compressione. La designazione è indicata da
2 valori, che corrispondono rispettivamente alle resistenze caratteristiche
riferiti a cilindri (fck) e a cubi (fc) . Alla valutazione della resistenza in
compressione continuano a prestarsi ugualmente bene i provini cubici e quelli
cilindrici, che possono anche essere di dimensioni piuttosto piccole. Tali
dimensioni sono giustificate dalle caratteristiche meccaniche più omogenee
della microstruttura dei calcestruzzi AR, che consentono di adottare provini
di minori dimensioni, con il grande vantaggio di poter usare le stesse presse
utilizzate per i calcestruzzi NR. Per quanto riguarda il rapporto fra resistenza
cilindrica e resistenza cubica, il suo valore si avvicina a 0,9, in quanto il
comportamento decisamente lineare fin quasi al picco della curva
sforzo-deformazione, senza aumento del modulo di Poisson
apparente, limita l'effetto di contenimento che le testate della pressa
esercitano sul provino, effetto che è la principale causa della maggiore
resistenza del cubo rispetto al cilindro. Infine, in mancanza di dati
provenienti dal controllo di qualità, si adotta anche per i calcestruzzi AR 8
N/mm2 lo scarto fra resistenza media fc
e resistenza caratteristica fck in
compressione cilindrica:
Resistenza
a trazione
I
calcestruzzi AR mostrano proporzionalmente una minore crescita della
resistenza a trazione in funzione di quella a compressione, rispetto ai
calcestruzzi NR. Per la resistenza media a trazione nei calcestuzzi
AR si può fare riferimento alla relazione proposta dal Codice-Modello MC90:
I frattili (inferiore, 5%, e
superiore, 95%) possono assumersi rispettivamente pari a fctk,min
= 0,68 fct e fctk,max
= 1,32 fct. A titolo di esempio si
vedano i valori contenuti nella tabella riportata sotto. RESISTENZA A TRAZIONE DIRETTA (N/mm2)
Per
la resistenza media a trazione indiretta per spacco (prova brasiliana) si può
fare riferimento alla seguente relazione:
Pertanto
il rapporto fct ¤ fct,sp
cade nell'intervallo 0,82 ¸ 0,86 per fck = 50
¸ 100 N/mm2, prossimo al valore
0,9 suggerito per i calcestruzzi NR (MC90). Modulo elastico
Il modulo di elasticità è una delle proprietà
meccaniche fondamentali di qualsiasi materiale elastico-lineare, omogeneo e
isotropo, e la sua conoscenza fornisce un dato essenziale per le applicazioni
strutturali. Mentre nel caso dei materiali a microstruttura molto fine (ad
esempio i materiali metallici) esiste in generale un esteso tratto iniziale
della curva sforzo-deformazione ad andamento quasi perfettamente lineare, e
quindi il modulo elastico (che ne è la pendenza) può essere tabellato ed
utilizzato senza alcun problema, nel caso dei materiali compositi che, come
il calcestruzzo, hanno microstruttura fortemente disomogenea, il modulo
elastico dipende da numerosi parametri. Essendo inoltre la curva
sforzo-deformazione dei materiali compositi in generale non lineare, il
modulo elastico va specificato o come pendenza inziale della suddetta curva (Eci = modulo dinamico) o come pendenza media (Ec = modulo secante). Nel caso del
calcestruzzo il modulo elastico è funzione della resistenza a compressione,
che a sua volta dipende dal tipo e dalla dimensione massima dell'aggregato,
dai rapporti di composizione dell'impasto e dalle condizioni di stagionatura. Per evitare di ricorrere alla determinazione
sperimentale, molti studi sono stati fatti nel passato per stabilire una
semplice relazione fra modulo elastico e resistenza a compressione. Tali
studi hanno avuto successo, tant'è che pressoché tutti i regolamenti
propongono relazioni fra modulo e resistenza. Anche per i calcestruzzi AR, come e ancor più che per i
calcestruzzi NR, non vi è proporzionalità semplice fra modulo elastico e
resistenza a compressione. Inoltre, mentre nei calcestruzzi NR il controllo
delle proprietà meccaniche è strettamente legato alla pasta legante, e quindi
il modulo elastico dipende poco dall'aggregato grosso, nei calcestruzzi AR
(in particolare per fc > 80 N/mm2) è l'aggregato grosso
ad influire decisamente sulle proprietà meccaniche, tant'è che impasti di
resistenza simile possono avere moduli elastici diversi a causa del diverso
aggregato. Comunque le formulazioni della relazione modulo
elastico - resistenza a compressione contenute nelle varie normative per
calcestruzzi NR continuano a valere anche per i calcestruzzi AR, a condizione
di ritarare i coefficienti numerici. Ad esempio:
Ricordando che il rapporto Eci/Ec è prossimo a 1,15, la relazione (6)
conferma le relazioni proposte per il
modulo dinamico da MC90 per i calcestruzzi AR:
Nella tabella sottostante si riportano i valori di Eci ottenuti dalla (7), con fc data dalla (1).
Coefficiente di contrazione trasversale
Se si limita l'attenzione al tratto iniziale
sensibilmente lineare della curva sforzo-deformazione, i risultati sperimentali
confermano la sostanziale identità di calcestruzzi AR e calcestruzzi NR (nc = 0,18 ¸ 0,24 per fc
crescente fino a 60 ¸ 70 N/mm2). Tuttavia, mentre nei
calcestruzzi NR il modulo di Poisson apparente
cresce rapidamente per valori tensionali ³ 0,80 fc,
a causa dell'estendersi della microfessurazione indotta dalla diversa
deformabilità di malta legante e aggragato grosso,
nei calcestruzzi AR la grande uniformità meccanica permette una maggiore
estensione del tratto lineare (fino a 0,90 ¸ 0,95 fc),
garantendo la costanza del modulo di Poisson fin
quasi al picco della curva sc-ec. La minore espansione trasversale (dilatanza) dei calcestruzzi AR spiega la loro minore
sensibilità al contenimento trasversale e quindi il loro comportamento meno
favorevole in regime triassiale di compressione, rispetto ai calcestruzzi NR. COMPORTAMENTO A FATICA
Il comportamento a fatica dei calcestruzzi è tuttora
non completamente noto, e ciò vale a maggior ragione per i calcestruzzi AR, ove
la presenza del fumo di silice modifica decisamente (e in meglio) le qualità
fisico-meccaniche della pasta cementizia, del suo interfaccia con le
particelle di aggregato e dell'aderenza con eventuali barre d'armatura o
fibre di rinforzo. Anche per i calcestruzzi AR le prove a frequenza,
ampiezza di ciclo e valore medio assegnati (prove di Wöhler)
permettono di ottenere le curve S-N (tensione di rottura a fatica S in
funzione del numero di cicli N), che sono rappresentabili con spezzate. E'
così possibile valutare la vita a fatica smax(N), ovvero il limite di fatica smax (N ® ¥), quest'ultimo spesso assunto pari a 0,3 ¸ 0,8 fc
(compressione semplice), ma i dati sperimentali sono ancora troppo scarsi. L'applicazione della REGOLA DI MINER, detta del
"danno cumulativo", trova per i calcestruzzi AR le stesse
difficoltà che per i calcestruzzi NR, ed al momento si accetta per il numero
di Miner il valore mediano prossimo a Calcestruzzo
non armato
· In compressione i calcestruzzi AR sembrano
avere una vita a fatica maggiore dei calcestruzzi ordinari per elevati valori
del rapporto smax/fc
(sforzo massimo applicato in rapporto alla resistenza statica a
compressione), mentre per valori bassi sembra verificarsi l'inverso; lo
stesso avviene nella fatica a trazione, ma le differenze rispetto ai
calcestruzzi ordinari sono minori; · I calcestruzzi AR presentano minori
deformazioni e minore caduta di rigidezza per fatica (in termini di riduzione
del modulo secante) rispetto ai calcestruzzi ordinari; · Il comportamento biassiale in compressione
perde le proprie caratteristiche di migliore resistenza (rispetto al
comportamento uniasssiale), dopo circa 50 cicli,
per qualunque rapporto fra le tensioni principali applicate, e il dominiio di rottura si riduce, assumento
una forma sempre più "quadrata" (resistenza in regime biassiale » resistenza in regime monoassiale); · Il tenore di umidità del calcestruzzo ha
molta influenza sul comportamento a fatica: con riferimento alla compressione
semplice, i calcestruzzi AR (ad aggregato normale o leggero) hanno
comportamento a fatica peggiore se il tenore di umidità è elevato
(maturazione e prova in acqua), contrariamente ai calcestruzzi NR; · Anche le condizioni ambientali e di prova
influenzano notevolmente il comportamento a fatica dei calcestruzzi AR: ad
esempio la pressione esterna d'acqua peggiora la vita a fatica, sia per
materiale inizialmente integro che fessurato; inoltre la vita a fatica in
aria è maggiore per i calcesruzzi di minore
resistenza (ad esempio fc = 60 N/mm2),
mentre l'opposto si verifica per i calcestruzzi di maggiore resistenza (ad
esempio fc = 110 N/mm2), il
tutto a parità di condizioni di maturazione. Calcestruzzo
armato
· Nei pilastri armati in calcestruzzo AR, al
rapido aumento degli spostamenti durante le prime miglia di cicli segue una
quasi totale stabilizzazione degli spostamenti, con loro aumento brusco solo
prima della rottura; nei pilastri in calcestruzzo NR l'aumento degli
spostamenti con il numero di cicli è più graduale; · Negli elementi armati soggetti a carichi
alternati (trazione + compressione), la fessurazione per trazione annulla il
contributo resistente del calcestruzzo teso, più rapidamente nei calcestruzzi
AR che nei calcestruzzi NR; · Negli elementi inflessi, la presenza del fumo di silice aumenta nettamente la vita a fatica nel caso di aggregato leggero, grazie alla migliore aderenza fra la pasta cementizia, l'aggregato e l'armatura; se sono presenti fibre, gli effetti benefici di fumo di silice e fibre sono più che additivi; Per il calcolo della durata di vita (numero di cicli a
rottura in presenza di determinati valori massimi e minimi di sforzo), ovvero
per la verifica di resistenza a fatica (per un assegnato numero di cicli), si
può fare riferimento ad un semplice modello del MC90:
dove:
con s c max = sforzo massimo di compressione applicato
al calcestruzzo
con s t max = sforzo massimo di trazione applicato al
calcestruzzo. Tale modello ha però i seguenti limiti: - per smin = 0,10 fct
il modello coglie per difetto i
valori sperimentali della resistenza a fatica alternata; - per smin = 0,30 fct
il modello sovrastima fortemente
la resistenza a fatica alternata; - per smin = 0,50 fct
il modello sottostima fortemente
la resistenza a fatica alternata. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ingegneriastrutturale.net -
Tutti i Diritti Riservati |