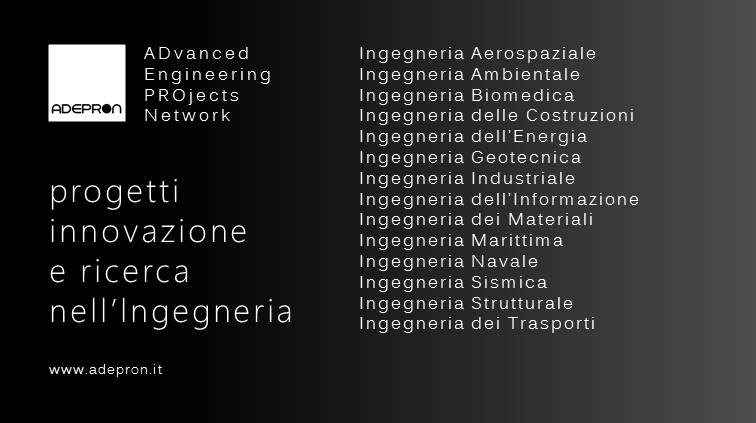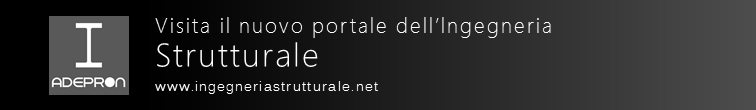|
· · Meccanica Computazionale · Modellazione Strutturale e Controllo
dei Risultati · · PROCEDURA PER · Marco Bozza · · INTRODUZIONE · SCELTA DEL
MATERIALE DELLA TIPOLOGIA E DEL METODO COSTRUTTIVO · SCELTA DEL PROCEDIMENTO DI ANALISI ·
· · · ·
· ·
INTRODUZIONE
La
modellazione strutturale consente di individuare gli schemi statici che
permettono di simulare in modo realistico, e il più possibile realistico, il comportamento
fisico reale della struttura. A tal fine è necessario saper scegliere il
procedimento di analisi che, nel caso specifico, permetta di conciliare
l'esattezza del risultato con la sicurezza e la praticità operativa e,
quindi, con l'economia del procedimento. La progettazione strutturale è,
quindi, un processo costituito da varie fasi, in particolare quattro: nella
prima parte il processo è di tipo ideativo (scelta del materiale, della
tipologia, delle modalità di costruzione, ecc.), nella seconda consiste nella
simulazione del comportamento fisico della struttura preliminarmente scelta
(scelta del modello di calcolo e calcolo), nella terza consiste nella
preparazione della documentazione necessaria alla realizzazione dell'opera,
nella quarta è di tipo estimativo (valutazione dei costi). La
definizione di uno schema strutturale che sia al tempo stesso abbastanza
semplice da essere agevolmente calcolabile e sufficientemente complesso da
mettere in conto l'effetto delle variabili più importanti, è un altro
problema cruciale della progettazione, in quanto da tale definizione dipende,
più ancora che l'esattezza numerica dell'analisi, l'attendibilità dei
risultati. L'avvento dei moderni procedimento di analisi ha indubbiamente
permesso di adottare modelli più complessi e quindi più attendibili che in
passato; in particolare ha consentito l'uso estensivo dei modelli
tridimensionali (modelli 3D). Tuttavia, data l'estrema difficoltà del fenomeno studiato, permangono non poche difficoltà, e l'ingegnere strutturista deve abituarsi ad operare a diversi livelli di complessità. Infatti se da una parte gli schemi molto semplificati trascurano molte variabili e sono, almeno in linea teorica, meno esatti, essi permettono tuttavia una interpretazione intuitiva del comportamento strutturale, e quindi una possibilità di controllo dei risultati, che sfugge invece facilmente agli schemi più complessi. Inoltre, per schemi semplificati, si ha a disposizione un'ampia gamma di metodi di analisi. Per schemi complessi si ha in pratica a disposizione un solo metodo quello degli elementi finiti. Quindi è opportuno adottare modellazioni assai semplici nella fase preliminare, riservando quelle più complesse alla fase di verifica finale, utilizzando ancora i risultati della fase preliminare per valutare l'attendibilità dei risultati finali. E' possibile distinguere tre livelli di modellazione: - modellazione a livello di struttura:
modellazione della struttura nel suo insieme; - modellazione a livello di elemento finito:
definizione del numero e tipo di elementi finiti in cui suddividere la
struttura; - modellazione a livello di materiale:
definizione delle leggi costitutive dei materiali. SCELTA
DEL MATERIALE DELLA TIPOLOGIA E DEL METODO COSTRUTTIVO
E'
questa la fase iniziale e più critica del processo: data la grande quantità
di tipologie disponibili la scelta della più idonea a soddisfare le esigenze
tecnico-economiche del progetto è un'operazione assai difficile, ed è stata
in passato fondata sulle opinioni più o meno soggettive del progettista. I
procedimenti approssimati di calcolo risultano importantissimi nella fase del
dimensionamento di massima, data la natura iterativa del processo di
dimensionamento, sia pure a spese dell'esattezza del calcolo. E' bene far notare a questo punto che il diffondersi del
metodo degli elemento finiti non ha diminuito l'importanza di tali metodi
approssimati, ma tende piuttosto a trasferirne l'uso alle fasi iniziali ed
ideative del processo. SCELTA
DEL PROCEDIMENTO DI ANALISI
L'impostazione
di un problema di analisi strutturale nasce dalla necessità di conoscere, fra
le varie informazioni che si ha a disposizione, quelle utili alla definizione
del sistema strutturale, quelle cioè riguardanti le parti di cui si vuole
conoscere il comportamento meccanico, sia esso statico o dinamico. In alcune
realizzazioni tale sistema coincide con la totalità del manufatto, in altre
esso è solo un sottoinsieme che va individuato ed estratto dal contesto
generale (ad es. il telaio di una macchina operatrice, la cellula di un
velivolo, il motore di un aereo, ecc.). Sull'oggetto dell'analisi va
precisato il tipo di problema da studiare, riconducibile ad uno di quelli di
seguito elencati, o ad una loro combinazione: - analisi statica o stazionaria; - analisi di stabilità (buckling); - analisi dinamica (modale, risposta in frequenza, time
history, ecc.); - analisi lineare; - analisi non lineare (per materiali, per geometria,
per vincoli). Va tenuto conto che ogni struttura è di per se solida,
e a rigore richiederebbe un'analisi tridimensionale. Risulta tuttavia più
agevole, ed anche più significativo, fare riferimento a modelli ridotti che,
in forma sintetica, siano in grado di cogliere gli aspetti più specifici
della struttura da analizzare. In tal modo: - le strutture con parti a prevalente sviluppo lineare
(travi, pilastri, ecc.) sono modellate con elementi monodimensionali (beam, truss) disposti nel piano
o nello spazio; - per strutture piane si fa riferimento a modelli a
lastra o a piastra, adottando elementi bidimensionali (shell); - per strutture sottili curve ci si riferisce a modelli
a guscio; - per strutture massicce (ad es. una diga) si fa inevitabilmente ricorso a modelli con elementi tridimensionali (elementi solidi 3D), verificando sempre se sia possibile risparmiare all'analisi geometrie o comportamenti prevedibili a priori (ad es. nel caso di strutture e carichi assialsimmetrici, come il vessel di un reattore nucleare, è sufficiente analizzare un quarto del modello). Nei casi di difficile classificazione, ovvero nei casi in cui certi comportamenti globali sono ben colti da un tipo di modello (ad es. 1D), mentre fenomeni diffusivi locali richiedono analisi di dettaglio impostate su modelli più complessi, conviene adottare una famiglia di modelli, caratterizzati da diversi livelli di affinamento, curando la possibilità di collegare trasversalmente i risultati ricavati con i vari schemi. |
||||||||||||||
|
ingegneriastrutturale.net - Tutti
i Diritti Riservati |