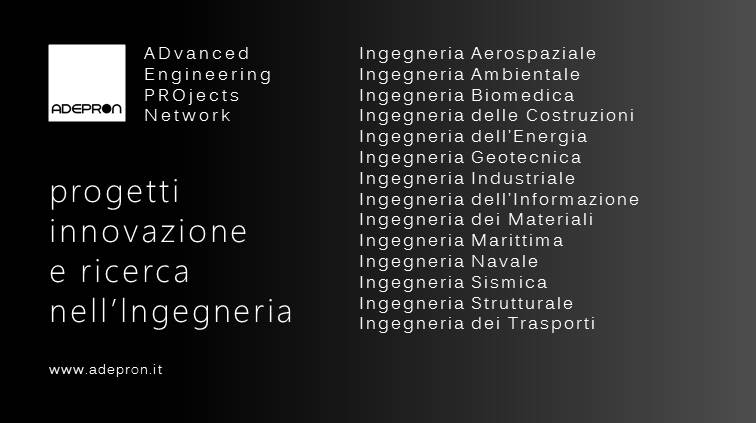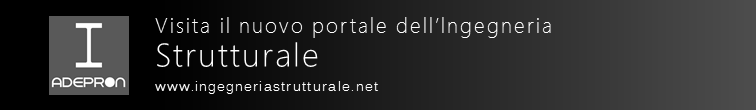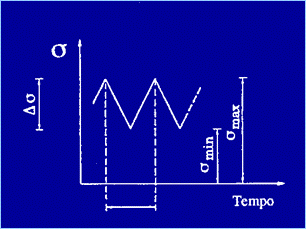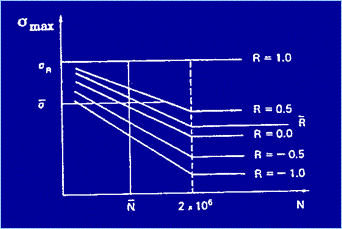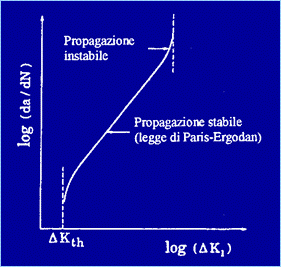|
· · Progetto e Sperimentazione di
Strutture · Progetto di Ponti e Viadotti · · FENOMENI DI FATICA NELLE STRUTTURE DA PONTE · Marco Bozza · · INTRODUZIONE · MODELLI SPERIMENTALI E TEORICI · CONSIDERAZIONI E SVILUPPI FUTURI · · · · ·
·
· INTRODUZIONE
Nella
progettazione degli elementi strutturali da ponte è necessario porre
particolare attenzione al fenomeno della fatica, ovvero a quel danneggiamento
causato nei materiali strutturali dall’ampiezza dell’oscillazione tensionale
agente dovuta alla ripetuta presenza di carichi ciclici. Nell’impalcato,
particolarmente soggetto ad un notevole flusso di traffico veicolare,
l’attenzione a questa problematica assume un’importanza di assoluto rilievo.
Se non ben valutata, la natura stessa del carico (ripetuti passaggi degli
automezzi) può indurre nell’impalcato un danneggiamento che, nei casi più
comuni, si manifesta con accentuate fessurazioni, punzonamenti
locali e perdita di aderenza delle armature. Nei casi più gravi si può
giungere alla rottura dell’elemento strutturale. La rottura per fatica è un
fenomeno di danneggiamento nel tempo, che di solito si innesca in zone ove si
hanno punte di tensione: inizia con micro-fessurazioni locali che, al
crescere delle ripetizioni del carico, si estendono progressivamente fino a
che, per eccessivo indebolimento della parte, si ha rottura. Zone
particolarmente delicate sono, ad esempio, quelle in corrispondenza delle saldature
di strutture di acciaio ove possono esserci autotensioni
dovute al loro ritiro e ove l’acciaio può essere reso fragile dal rapido
raffreddamento. I modelli teorici per lo studio del fenomeno si basano
su concetti propri della meccanica della frattura, poiché la crisi per fatica
è legata alla propagazione dei difetti presenti nell’elemento soggetto a
carichi ciclici. Ricordando MODELLI
SPERIMENTALI E TEORICI
Si richiamano brevemente i concetti fondamentali che
stanno alla base di due classici approcci allo studio della fatica: uno di
tipo sperimentale (diagrammi di Wöhler) e
uno di tipo teorico (legge di Paris-Erdogan). Diagrammi
di Wöhler
I diagrammi di Wöhler sono
stati ottenuti effettuando numerose prove sperimentali su provini di acciaio
sottoposti a carichi ciclici di ampiezza costante Ds = smax - smin (Figura 1), e diagrammando il numero N di
cicli (vita a fatica) per il quale il provino andava a rottura, in funzione
della tensione ciclica massima smax e del rapporto di fatica R = smin/smax (Figura 2). In sostanza per rilevare i
punti della curva si mantiene costante il ciclo di carico e si rileva il
numero di cicli necessario per la rottura. Naturalmente per ogni particolare
tipo di cicli di carico si avrà una diversa curva di Wöhler.
Figura 1
Figura 2 Da queste curve sperimentali si osserva che, per un
generico valore di R, la tensione di rottura diminuisce all’aumentare di N,
ma si mantiene poi costante (limite di fatica) per un numero di cicli
superiore a circa 2·106. La conseguenza che se ne ricava è che, se
la tensione massima del carico ciclico rimane inferiore al valore definito
dall’asintoto orizzontale (Figura 2), l’elemento strutturale non raggiunge la
crisi per fatica, neppure dopo un elevato numero di cicli. Legge
di Paris-Erdogan
La legge di Paris-Erdogan è una formulazione teorica che utilizza alcuni parametri della Meccanica della Frattura, nella quale la crisi per fatica è collegata alla propagazione di una o più fessure presenti nella struttura. Essa afferma che la velocità di propagazione della fessura da/dN risulta funzione della variazione del fattore di intensità degli sforzi DK presente all’apice della fessura stessa, secondo la relazione:
essendo: - a = profondità di una fessura passante, presente nella struttura in esame; - N = numero di cicli a cui è sottoposta la struttura; - DK = YDs(pa)1/2 = variazione dello Stress Intensità Factor (Y dipende dalla geometri della fessura e della struttura); - A, m = costanti empiriche del materiale.
Rappresentando la (1) in un diagramma bilogaritmico essa corrisponde ad una retta di pendenza m, mentre in realtà la curva sperimentale presenta due asintoti verticali (Figura 3).
Figura 3
Questi ultimi corrispondono, rispettivamente, alla soglia inferiore, sotto la quale non si manifesta la propagazione stabile della fessura, e alla soglia superiore, in corrispondenza della quale la propagazione diventa instabile, poiché viene raggiunto il valore di tenacità a frattura Kc del materiale. Si osservi che, sebbene la (1) non consideri l’influenza del rapporto di fatica R, la legge di Paris-Erdogan è molto utilizzata nello studio della propagazione a fatica dei difetti, poiché è di semplice applicazione. Inoltre essa fornisce risultati sufficientemente precisi dal punto di vista ingegneristico. CONSIDERAZIONI E SVILUPPI
FUTURI I meccanismi di collasso strutturale che possono
intervenire in una struttura da ponte, durante una crisi di fatica, possono
essere: - lo snervamento dell’acciaio; - sfilamento delle barre di armatura longitudinale
(pull-out); - frattura del calcestruzzo. L’analisi di questi meccanismi richiede uno studio
teorico-sperimentale molto complesso, intervenendo fenomeni fortemente non
lineari, la cui reciproche interazioni, sia a livello locale che globale per
la struttura, non sono ancora completamente comprese fino in fondo. Tuttavia,
gli attuali approcci per lo studio dei fenomeni di fatica fanno riferimento a
modelli teorici, che per essere vantaggiosamente utilizzati a scopi
ingegneristici devono possedere due requisiti importanti: - presentare, da un lato, una semplicità operativa in
grado di sintetizzare la complessa realtà che si manifesta lungo i
numerosissimi cicli di sollecitazione; - essere in grado, dall’altro, di valutare
compiutamente le grandezze significative presenti, scelte forzatamente in
numero ridotto. Per questo motivo la ricerca è impegnata in ulteriori studi, soprattutto per analizzare il comportamento di tipologie strutturali e materiali sempre più frequentemente utilizzati negli impalcati da ponte, come ad esempio le travi principali in calcestruzzo armato precompresso. In questo caso, infatti, è di notevole interesse analizzare l’influenza che esercita il ruolo sostenuto dalla precompressione nel fenomeno della fatica. L’importanza di questo ruolo si spiega pensando alla presenza degli specifici livelli tensionali che sempre accompagnano il fenomeno della fatica. Il diverso valore della escursione tensionale che si rileva nelle strutture in calcestruzzo armato precompresso, rispetto a quelle in calcestruzzo armato ordinario, fa prevedere un’importante differenza di comportamento nei riguardi della fatica per le due diverse situazioni strutturali. Tale differenza richiede quindi ancora studi specifici che siano in grado di produrre trattazioni unitarie sulla materia, oggi, tuttavia, ancora separate da approcci indipendenti di tipo teorico e sperimentale. |
||||||||||||||||
|
ingegneriastrutturale.net -
Tutti i Diritti Riservati |