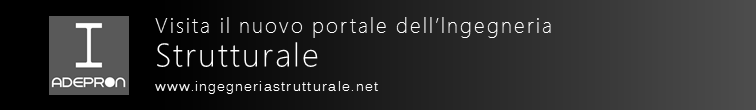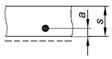|
· Normativa e Sicurezza
Strutturale · Norme Tecniche per le Costruzioni · · IL COPRIFERRO PER LE STRUTTURE IN C.A. ALLA LUCE DELLE NORME · TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (D.M. 14.01.2008) (*) · Luigi Coppola Alessandra Buoso · · INTRODUZIONE · copriferro minimo, copriferro nominale e
tolleranza di esecuzione · 1. Copriferro minimo per garantire durabilità (cmin,d) · 2. Copriferro minimo per garantire durabilità (cmin,d) · 3. Coefficienti
correttivi per copriferro minimo durabilità (cmin,d) · 4. Copriferro minimo per garantire resistenza al
fuoco (cmin,f) · 5. Casi particolari per copriferro minimo · 6. Tolleranza di esecuzione relativa al
copriferro (Dcdev)
· 7. Copriferro nominale cNOM · 8. Accorgimenti
ulteriori :armatura di pelle del copriferro
· Esempi riassuntivI per il calcolo del copriferro (*) Articolo già
pubblicato nella rivista “L'Edilizia – Building and Construction for
Engineers", N. 155 / 2008 Introduzione Molte
volte ci siamo chiesti se esista per un determinato elemento strutturale un
solo copriferro oppure se di fatto ne esistano due. A questo termine, infatti,
non tutti attribuiscono lo stesso significato: · il calcolatore strutturale identifica come
copriferro, ad esempio in una trave, la distanza tra il baricentro
dell’armatura disposta per assorbire la caratteristica flettente e la
superficie esterna dell’elemento strutturale; · la normativa vigente ed, in particolare, le
Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.01.2008), in accordo
all’Eurocodice 2 (UNI EN 1992-1-1), definisce, invece, il copriferro come la distanza tra la superficie esterna dell’armatura
(inclusi staffe, collegamenti e rinforzi superficiali, se presenti) più
prossima alla superficie del calcestruzzo e la superficie stessa del
calcestruzzo. Il
copriferro, in accordo alle Norme Tecniche, quindi, individua lo spessore di
calcestruzzo che ricopre l’armatura più esterna. Si intuisce da quanto sopra riportato come il diverso significato attribuito al termine “copriferro” possa generare non poca confusione. Si pensi, ad esempio, ad una trave emergente la cui armatura all’intradosso della sezione di mezzeria sia costituita da ferri Φ16 e staffe Φ8 con uno spessore netto di ricoprimento di calcestruzzo di 10 mm. In accordo con le Norme Tecniche, quindi, il copriferro è di 10 mm. Per il calcolatore strutturale, invece, il copriferro vale circa 25 mm (spessore di calcestruzzo: 10 mm + diametro della staffa: 8 mm + raggio dell’armatura principale: 8 mm = 26 mm). Negli elaborati progettuali di questo elemento inflesso verrà riportato nella quasi totalità dei casi come valore del copriferro, erroneamente, 25 mm quando, in realtà, il copriferro effettivo, in accordo alle Norme Tecniche, risulta di appena 10 mm. La situazione ipotizzata, presenta non pochi problemi, non tanto dal punto di vista del calcolo strutturale - il quale, come ben noto, si basa proprio sul valore della distanza del baricentro dell’armatura principale dalla superficie esterna dell’elemento in calcestruzzo necessaria ai fini dell’individuazione del braccio della coppia interna e, quindi, del momento resistente - quanto ai fini della corretta trasmissione degli sforzi tra acciaio e calcestruzzo, della prevenzione dell’acciaio dalla corrosione promossa dagli agenti aggressivi ambientali (anidride carbonica e cloruri) e della protezione dell’acciaio dall’incendio. L’errore di
confondere la distanza del baricentro dell’armatura principale dalla
superficie esterna dell’elemento con il copriferro conduce ad un
sottodimensionamento del copriferro effettivo che può riflettersi, quindi, in
un limitato sviluppo delle tensioni di aderenza acciaio-calcestruzzo, in una
precoce corrosione delle barre soprattutto negli elementi esposti all’esterno
(in particolar modo quelli esposti all’azione dell’acqua di mare, ai sali
disgelanti a base di cloruro o all’azione dell’anidride carbonica atmosferica)
e, infine, in un elevato rischio di collasso delle barre in occasione di
eventi accidentali quali l’incendio. Il
presente articolo, quindi, vuole fornire un contributo pratico per un
corretto dimensionamento del copriferro ove a questo termine si attribuisce
il significato stabilito dalle Norme Tecniche (D.M. 14.01.2008). Queste
ultime al punto 4.1.6.1.3 (“Copriferro
e interferro”) indicano che “L’armatura
resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo”
senza fissarne un limite inferiore (una volta di 20mm in accordo al D.M.
9.01.96 e a quello del 23.09.2005). Le Norme Tecniche, inoltre, stabiliscono
che il valore minimo del copriferro deve essere individuato sulla base delle
seguenti considerazioni: · la verifica allo stato limite di
fessurazione secondo il § 4.1.2.2.4 NTC · un sufficiente sviluppo delle tensioni di
aderenza acciaio/calcestruzzo (vedi Eurocodice 2 – parte 1) · la protezione delle armature dalla
corrosione (vedi Eurocodice 2 – parte 1) · la resistenza al fuoco della struttura
(vedi Eurocodice 2 – parte 2) Di
seguito, quindi, viene presentato l’iter progettuale che conduce alla scelta
del valore minimo di copriferro in accordo ai dettami sopra menzionati
richiesti dalle Norme Tecniche. Per quanto concerne la sola verifica agli
stati limite di esercizio, per la limitazione della fessurazione, essendo
essa strettamente correlata al dimensionamento strutturale, non sarà trattata
direttamente nel presente articolo. Questa verifica, infatti, dipende dal dimensionamento
dello specifico elemento strutturale in c.a. o c.a.p. e, quindi, non può
essere ricondotto, in questa sede, ad una trattazione di tipo generalista. Prima di
procedere nella presentazione della metodologia di valutazione del copriferro
ci preme sottolineare come un suo corretto dimensionamento possa consentire,
unitamente ad una attenta calcolazione strutturale e alla scelta di un
calcestruzzo durevole, di raggiungere un maggior livello di protezione delle
strutture nei confronti del fuoco e delle azioni aggressive ambientali con
inevitabili ricadute positive sia sulla sicurezza strutturale dell’opera che
sulla riduzione dei costi di manutenzione prevenendo i fenomeni di degrado
tipici di strutture con copriferri modesti. Queste considerazioni evidenziano
ancora una volta come centrale risulti il ruolo del progettista calcolatore
strutturale nel definire un adeguato spessore di copriferro, dell’impresa nel
rispettarlo con l’adozione di opportuni distanziatori e della Direzione
Lavori e del Collaudatore in corso d’opera cui si demanda il compito di
controllare che lo spessore definito dal progettista/calcolatore sia stato
rispettato dall’impresa esecutrice. Copriferro minimo,
copriferro nominale e tolleranza di esecuzione In accordo
con l’Eurocodice 2, il copriferro da utilizzare nei calcoli strutturali e da
riportare negli elaborati grafici si definisce come copriferro nominale (cNOM) dato da:
dove: · cmin = valore
del copriferro minimo · Dcdev = tolleranza di esecuzione
relativa al copriferro Lo
spessore minimo del copriferro sarà il valore massimo tra quelli minimi imposti
per soddisfare le esigenze di durabilità, di aderenza e di resistenza al
fuoco (Figura 1), secondo la relazione:
dove: · cmin,b = copriferro
minimo necessario per l’aderenza delle armature · cmin,dur = copriferro minimo necessario per la durabilità
dell’opera · Dcdur,g = valore aggiuntivo del copriferro legato alla sicurezza · Dcdur,st =
riduzione del copriferro quando si utilizza acciaio inossidabile · Dcdur,add =
riduzione del copriferro minimo quando si ricorre a protezioni aggiuntive · cmin,f = copriferro minimo necessario per la resistenza al
fuoco dell’opera
Figura 1 – Il
ruolo del copriferro 1. Copriferro minimo per garantire l’aderenza acciaio/calcestruzzo (cmin,b)
Relativamente allo spessore minimo per garantire una corretta
trasmissione degli sforzi tra armatura e calcestruzzo (cmin,b) si farà riferimento al diametro delle barre
ordinarie, a quello delle guaine (nelle strutture post-tese) e a quello dei
trefoli o dei fili nelle strutture pre-tese secondo quanto riportato in
Tabella 1. Da sottolineare che per armature ordinarie, sia in barre singole
che raggruppate, immerse in un calcestruzzo avente diametro massimo
dell’aggregato maggiore di 32 mm (in accordo alla serie normalizzata + serie
1, aggregati aventi diametro massimo di 40
oppure 63 mm), il valore minimo del copriferro da imporre per
garantire una corretta aderenza tra barre e conglomerato sarà pari al
diametro delle barre aumentato di 5 mm.
Tabella 1 – Calcolo del
copriferro minimo atto a garantire una corretta trasmissione degli sforzi tra
armatura e calcestruzzo (cmin,b) in funzione del tipo di armatura 2. Copriferro minimo per garantire durabilità (cmin,dur)
Il
copriferro riveste un ruolo di primaria importanza in quei contesti in cui il
degrado prevalente è rappresentato dalla corrosione dei ferri di armatura.
L’adozione di un copriferro sufficientemente spesso, infatti, consente di
allungare il cammino che le sostanze depassivanti (anidride carbonica e
cloruri) debbono percorrere per raggiungere l’armatura. Pertanto, più grande
risulterà lo spessore maggiore sarà il tempo di innesco del processo di
corrosione dell’acciaio e, conseguentemente, la struttura avrà una vita
nominale più prolungata. A tal
proposito, in accordo alle NTC, paragrafo 2.4, il progettista deve dichiarare
nei documenti progettuali la vita
nominale da assegnare alla struttura in funzione della sua importanza e
della classe d’uso; si ricorda che per
opere ordinarie la vita nominale è di 50 anni. Nello
specifico, per quanto attiene alla scelta del copriferro minimo per il
rispetto delle condizioni di durabilità, (cmin,dur), l’Eurocodice
2 (UNI EN 1992-1-1) fornisce, in forma tabellare i valori del copriferro
minimo in funzione del tipo di armatura (lenta o da precompressione), della classificazione strutturale e delle
classi di esposizione ambientale cui l’elemento in calcestruzzo ricade
(Tabella 2). Nel draft dell’Appendice nazionale dell’Eurocodice 2 si
stabilisce che le costruzioni, con
vita nominale di 50 anni, ricadano in classe strutturale S4 e, pertanto,
i valori minimi del copriferro sia per c.a. che c.a.p., possono essere
dedotti direttamente dalla Tabella 2 alla riga corrispondente a tale classe
strutturale (S4) in funzione della classe di esposizione ambientale (X0, XC,
XD e XS).
Tabella 2 – Valori minimi del
copriferro (cmin,dur) atti a garantire la durabilità in funzione
della classe di esposizione ambientale e della classe strutturale dell’opera
(i valori tra parentesi sono relativi alle opere in c.a.p.) I
valori minimi del copriferro riportati in Tabella 2 debbono essere
opportunamente modificati se: ·
si prevede un
incremento della vita nominale di progetto ·
si utilizza
calcestruzzo con una classe di resistenza superiore rispetto a quella minima
imposta dai prospetti della durabilità riportati nella UNI 11104 ·
l’elemento da
realizzare ha una forma particolare ·
si esercitano
controlli di qualità speciali sulle forniture di calcestruzzo In
queste situazioni, partendo dalla classe strutturale S4, si procederà in
accordo al prospetto riportato in Tabella 3 ad aumentare o diminuire la
classe strutturale secondo le specifiche esigenze che di volta in volta si
presenteranno durante l’iter progettuale. Ad
esempio, se per gli elementi interni in classe di esposizione XC1, per
garantire i requisiti strutturali, si debba prescrivere un calcestruzzo in
classe di resistenza C32/40, maggiore di quella minima (C25/30) prevista per
garantire la durabilità in questa classe di esposizione, sarà possibile
ridurre gli elementi che si stanno dimensionando di una classe strutturale,
che verranno classificati S3 in luogo di S4. Pertanto, per questi elementi
(classe strutturale S3) il copriferro minimo potrà essere ridotto da 15 mm a
10 mm.
Tabella 3 – Classificazione
strutturale in accordo UNI EN 1992-1-1 Quando,
invece, la vita nominale da garantire per l’opera ha una durata superiore a
50 anni ed, in particolare pari a 100 anni, è necessario intervenire
aumentando gli spessori di copriferro previsti, a parità di tutte le
condizioni per le opere con vita nominale di 50 anni. L’aumento della vita
nominale, infatti, comporta delle variazioni sostanziali sulla dimensione del
copriferro per le classi di esposizione XC, XD ed XS, laddove il calcestruzzo
svolge un ruolo preventivo della corrosione dei ferri di armatura. Nel caso,
invece, di strutture esposte alle classi XF1/XF3 (azione dei cicli di
gelo-disgelo in assenza di sali disgelanti) ed XA (strutture interrate o
idrauliche a contatto con terreni e acque aggressive), dove l’aggressione
ambientale si rivolge esclusivamente nei confronti della matrice cementizia,
aumentare lo spessore del copriferro non ha alcun beneficio sulla vita
nominale della struttura. In questi casi risulta, invece, necessario
ricorrere ad un calcestruzzo con una maggiore classe di resistenza
caratteristica (quindi, con un minore rapporto a/c) in grado di ostacolare la
penetrazione della sostanza aggressiva o prevedere l’utilizzo di un
rivestimento protettivo superficiale di natura epossidica, poliuretanica o a
base di malte polimero-cemento. Nel caso
di strutture aeree (classe di esposizione XC), marine (XS) o soggette al
trattamento con sali disgelanti a base di cloruro (XF2 e XF4 che
conseguentemente ricadono anche nella classe di esposizione XD) alle quali
viene assegnata una vita nominale maggiore di 50 anni, è necessario, quindi,
procedere al calcolo del copriferro che si sviluppa, da una parte secondo
l’Eurocodice 2 (Tabella 2 e 3) e, dall’altra, calcolando direttamente gli
spessori minimi da garantire a protezione delle armature per l’intera vita
nominale dell’opera desunti, come meglio verrà specificato nel seguito, dalle
leggi di diffusione delle sostanze aggressive nel calcestruzzo (CO2
+ Cl-). Occorrerà, quindi, confrontare tra i valori ottenuti del
copriferro quello più stringente (cioè quello di maggiore spessore) che
costituirà il copriferro minimo per la durabilità (cmin,dur) da
assegnare all’opera. Nel paragrafo che segue viene illustrata in dettaglio la
procedura per l’individuazione di cmin,dur per strutture con vita
nominale maggiore di 50 anni. 2.1 Calcolo del copriferro per
strutture con vita nominale di 100 anni
mediante Eurocodice 2
Il calcolo
del copriferro in accordo con la procedura definita dall’Eurocodice 2 è
valido solo nel caso in cui la vita nominale assegnata alla struttura sia
pari a 100 anni. Per vite nominali maggiori lo spessore minimo del copriferro
per garantire la durabilità deve necessariamente essere condotto con le
procedure descritte nei due paragrafi che seguono basate sulle leggi di
diffusione dell’anidride carbonica e del cloruro nel calcestruzzo. Come già
menzionato, in accordo con l’Eurocodice 2, un’opera con vita nominale di 50
anni ricade in classe strutturale S4.
Lo stesso Eurocodice stabilisce che se la vita nominale è di 100 anni occorre
aumentare la classe strutturale di 2 (Tabella 3). Pertanto, in via del tutto
generale una struttura con vita nominale di 100 anni ricade in classe
strutturale S6 (S4 + 2). Nota la classe strutturale sarà, quindi, di facile
individuazione lo spessore minimo del copriferro consultando la Tabella 2 una
volta nota la classe di esposizione ambientale in cui l’elemento strutturale
ricade. Ad
esempio, nel caso delle pile di un viadotto, situato in una zona a clima
temperato, ricadente nella classe di esposizione XC4, realizzato con un
calcestruzzo di resistenza caratteristica pari a 40 N/mm2, il copriferro
per la durabilità sarà pari a 30 mm e 40 mm rispettivamente se per l’opera è
prevista una vita nominale di 50 e 100 anni. In sostanza, come si può notare
dalla consultazione della Tabella 2, l’incremento della vita nominale di
un’opera da 50 a 100 anni comporta, in accordo all’Eurocodice 2, a pari Rck
del calcestruzzo, un aumento dello spessore minimo del copriferro di 10 mm
indipendentemente dalla classe di esposizione ambientale in cui la stessa
ricade. Come si può notare, dalla consultazione delle Tabelle 2 e 3, inoltre,
al fine di ridurre lo spessore minimo del copriferro può essere opportuno
ricorrere all’impiego di un calcestruzzo di classe di resistenza
caratteristica più elevata (Tabella 3) riducendo la classe strutturale da S6
a S5 con una diminuzione dello spessore di copriferro di 5 mm. Il valore
del copriferro ottenuto con la procedura definita dall’Eurocodice 2 deve
essere confrontato con gli spessori di copriferro determinati mediante le
leggi di diffusione del cloruro e dell’anidride carbonica che vengono
discusse nei due paragrafi che seguono. Al solito, il valore definitivo che
verrà adottato per il copriferro minimo sarà il maggiore tra quelli
individuati con la procedura definita dall’Eurocodice 2 e quelli stabiliti
con le leggi di diffusione delle sostanze aggressive (anidride carbonica e
cloruri). Le leggi
di diffusione delle sostanze depassivanti dell’acciaio (anidride carbonica e
cloruri) nel calcestruzzo si presentano più flessibili rispetto al metodo
proposto dall’Eurocodice 2 utilizzabile solo per vite nominali pari a 100
anni. Le procedure che si basano sull’utilizzo delle leggi di
diffusione,infatti, possono essere adottate per vite nominali maggiori di 50
anni e diverse da 100 anni. Ad esempio, possono essere utilizzate per
strutture di particolare valenza strategica, come il Ponte sullo Stretto di
Messina dove si richiede una vita nominale di 200 anni oppure nella
progettazione dei depositi di rifiuti nucleari dove la vita nominale
richiesta può addirittura risultare di 500 anni. 2.2 Calcolo del copriferro per
strutture con vita nominale maggiore di 50 anni esposte al rischio di
corrosione promossa dalla carbonatazione (classe di esposizione XC)
L’espressione
che correla lo spessore del copriferro cfCO2 di strutture esposte
al rischio di corrosione per effetto dell’anidride carbonica con la vita
nominale t* è data da:
dove: · cfCO2 è il copriferro minimo (in
mm) per strutture esposte all’anidride carbonica · t* è vita nominale della struttura (in
anni) · KcorrCO2 è la costante di
diffusione della CO2 corretta in base al rischio di corrosione (in
mm/anni1/2) Nella
Tabella 4 vengono riportati i valori della costante di diffusione della CO2
(KcorrCO2) (1) per
diversi conglomerati maturati a umido per 7 giorni prima dell’esposizione
all’ anidride carbonica, in funzione delle condizioni ambientali e della
resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cubici (Rck).
Tabella 4 – Valori della
costante KcorrCO2 per calcestruzzi (maturati a umido per 7 giorni)
con diverse resistenze meccaniche a compressione esposti in ambienti interni
ed esterni NOTA (1) La costante KcorrCO2 non tiene conto soltanto della
velocità di ingresso della CO2 nel calcestruzzo, ma anche del
rischio di corrosione delle barre connesso con la presenza di acqua e di
ossigeno. Si fa notare come, la velocità di diffusione
della CO2 per le strutture all’interno risulta maggiore di quella
delle strutture esposte all’esterno. Tuttavia, gli elementi in c.a. che si
trovano all’interno di un fabbricato, per via dell’elevata resistività
derivante dal copriferro asciutto, sono quelli esposte ad un rischio
praticamente nullo di corrosione. Questo spiega il perché il coefficiente
KcorrCO2 per le strutture
esterne sia maggiore di quelle interne anche se nella realtà la
carbonatazione procede con una maggiore velocità nelle strutture asciutte all’interno
di un fabbricato. L’introduzione di questo coefficiente KcorrCO2,
in luogo della semplice costante di diffusione della CO2 che tiene
conto solo della velocità di ingresso dell’anidride carbonica, si rende, in sostanza, necessaria al fine di evitare una sovrastima del
copriferro per gli elementi interni pochi esposti al rischio di corrosione
(ma fortemente carbonatati) e, per contro, una sottostima del copriferro per
le strutture esterne fortemente esposte al rischio di corrosione, ma poco carbonatate. L’espressione
sopra riportata può essere utilizzata per il calcolo dello spessore minimo
del copriferro una volta nota la resistenza caratteristica (e, quindi, la
costante KcorrCO2) imponendo t* pari alla vita nominale prefissata
per la struttura. Risolvendo, quindi, l’equazione rispetto a cfCO2
si ottiene lo spessore minimo del copriferro. Per una
maggiore comprensione di quanto sopra espresso si faccia riferimento al
viadotto situato in clima temperato di cui al precedente paragrafo di valenza
strategica e per il quale si vuole garantire una vita nominale di 100 anni.
Si tratta di un’opera che ricade nella classe di esposizione XC4 per la quale
si prevede di utilizzare un calcestruzzo con resistenza caratteristica di 40
N/mm2 conforme a quella minima indicata per la durabilità dalla
norma UNI 11104. Per il coefficiente KcorrCO2, si adotta il valore
desunto dalla Tabella 4 per le strutture esposte all’esterno (KcorrCO2
= 2.04). Fissato il tempo t* pari alla vita nominale dell’opera (100 anni) si
ha:
Il valore
ottenuto va confrontato con quello desunto dall’Eurocodice 2. Per la struttura
in esame dal paragrafo precedente era emerso un copriferro minimo di 40 mm.
Pertanto, si può concludere che per le pile del viadotto in esame il
copriferro minimo per la durabilità (cmin,dur) sarà quello
maggiore desunto dalla procedura suggerita dall’Eurocodice 2 e pari a 40 mm. 2.3 Calcolo del copriferro per strutture con vita
nominale maggiore di 50 anni esposte al rischio di corrosione promossa dai
cloruri (classe di esposizione XD e XS).
L’espressione
che correla lo spessore del copriferro di strutture esposte al rischio di
corrosione da cloruri cfCl con la vita nominale t* è data da:
dove : · t* = è la vita nominale della struttura
(in anni) · Dapp = coefficiente di
diffusione apparente del cloruro nel calcestruzzo (m2/s) · dx = strato di convenzione (mm) Il valore del coefficiente di diffusione apparente (Dapp)
di calcestruzzi confezionati con cemento Portland è riportato in Tabella 5.
Per calcestruzzi confezionati con cementi diversi da quelli Portland (tipo I)
il coefficiente di diffusione deve essere opportunamente corretto
moltiplicandolo per il coefficiente riportato in Tabella 6 in funzione del
tipo di cemento utilizzato. Come si può notare, ai fini della diminuzione
dello spessore del copriferro i cementi pozzolanici (tipo IV) e d’altoforno
(tipo III) sono da privilegiarsi in luogo di quelli portland o portland al
calcare. La riduzione del copriferro conseguente all’impiego dei cementi tipo
III e IV discende dalla capacità dei prodotti di idratazione dei cementi
pozzolanici di rallentare la diffusione del cloruro. Per i valori dello
spessore dello strato di convezione, infine, si potrà fare riferimento alla
Tabella 7.
Tabella 5 – Coefficiente di
diffusione apparente del cloruro in calcestruzzi confezionati con cemento
Portland di tipo I
Tabella 6 – Coefficiente di
correzione di Dapp per calcestruzzi confezionati con cementi
diversi dal tipo I.
Tabella 7 – Spessore dello strato
di convezione in funzione della resistenza caratteristica del conglomerato
misurata su provini cubici Allo scopo
di chiarire in che modo utilizzare la correlazione sopra riportata, si prenda
in esame a titolo di esempio una vasca di contenimento di acque contenenti
cloruri di un impianto industriale per la quale si prevede una vita nominale
di 100 anni. La struttura, realizzata con un calcestruzzo di classe di
resistenza 40 N/mm2, ricade nella classe di esposizione XC2 (strutture
permanentemente immerse) e in quella XD2 (strutture in contatto con acque
contenenti cloruri). In accordo con l’Eurocodice 2, gli elementi di questa
opera ricadono in classe strutturale S6 e il copriferro minimo è pari a 45 mm
(il maggiore tra quello previsto per la classe di esposizione XC2 – 35 mm – e
quello richiesto per la classe di esposizione XD2: 45 mm). Nella ipotesi di
confezionare il calcestruzzo con un cemento CEM II A-L 42.5R otteniamo per lo
spessore di copriferro:
Tra i valori calcolati con i due metodi suddetti si sceglierà quello più stringente, ossia il maggiore. Tuttavia, nel caso specifico lo spessore del copriferro maggiore (140 mm) ovviamente risulta improponibile, sia per motivi di carattere tecnico (si pensi alla fessurazione intensa che uno spessore così elevato di calcestruzzo non armato presenterebbe), ma anche di carattere economico. Lo spessore elevato, determinato nel caso in esame, è la diretta conseguenza di una scelta non adeguata del tipo di cemento. Il cemento al calcare, infatti, non si presenta particolarmente adatto per realizzare calcestruzzi destinati a strutture esposte ai cloruri in quanto poco incline a rallentare la diffusione di questi ioni nel calcestruzzo. Indipendentemente da queste considerazioni, è opportuno ricordare come spessori minimi del copriferro maggiori di 50 mm presentano un elevato rischio fessurativo la cui attenuazione è demandata all’impiego di “armature di pelle” realizzate con acciai non sensibili alla corrosione (acciaio inox, zincato). Quando lo spessore minimo del copriferro, quindi, risulta maggiore di 70 mm potrebbe essere necessario ricorrere, al fine di ridurlo entro il limite suggerito: · all’impiego di un calcestruzzo con una
classe di resistenza caratteristica a compressione superiore; · cambiare tipo di cemento optando per quelli
(principalmente pozzolanici e d’altoforno) capaci di rallentare la diffusione
del cloruro nel calcestruzzo. Ad esempio, per la struttura precedentemente analizzata sostituendo il cemento Portland al calcare con un cemento d’altoforno di CEM III/B 42.5R si ha :
Con questo
ultimo cemento, quindi, il copriferro minimo calcolato in base alla legge di
diffusione del cloruro (60 mm) risulta più stringente di quello (45 mm)
individuato in accordo alla procedura definita dall’Eurocodice 2. Pertanto,
adotteremo per la struttura in esame un copriferro minimo ai fini della
durabilità (cmin,dur) pari a 60 mm. 3. Coefficienti correttivi per copriferro minimo durabilità (cmin,dur)
Gli altri
valori riportati nell’espressione per il calcolo del copriferro minimo individuano: · Dcdur,g = margine di sicurezza
aggiunto Nel
draft dell’appendice nazionale dell’Italia, si consiglia di porre tale valore
pari a zero. · Dcdur,st = riduzione del copriferro minimo quando si
utilizza acciaio inossidabile Nel
draft dell’appendice nazionale dell’Italia, si consiglia di porre tale valore
pari a zero. · Dcdur,add = riduzione del copriferro minimo quando si
ricorre a protezioni aggiuntive Nel
draft dell’appendice nazionale dell’Italia, si consiglia di porre tale valore
pari a zero. 4. Copriferro minimo per garantire resistenza al fuoco (cmin,f)
Nelle
Norme Tecniche per le costruzione al paragrafo 4.1.13 si afferma che “Le verifiche di resistenza al fuoco
potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2, utilizzando i coefficienti
gM (v. § 4.1.4) relativi alle combinazioni
eccezionali ed assumendo il coefficiente acc pari a 1.0”. Nella seconda parte dell’Eurocodice 2,
infatti, si riportano i criteri di progettazione per strutture resistenti al fuoco.
In tale articolo però si vogliono dare degli utili, quanto pratici,
riferimenti per il calcolo non dell’intera struttura, ma solo del valore del
copriferro minimo per garantire la resistenza al fuoco. Nel
Decreto Ministeriale 09/03/2007 “Prestazioni
di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, S.O.G.U. del 29.03.2007 n. 87,
nell’Appendice C si afferma che in attesa della pubblicazione delle Appendici
Nazionali degli Eurocodici, è possibile limitare l’impiego dei metodi di
calcolo alla sola verifica della resistenza al fuoco degli elementi
costruttivi portanti in accordo alla norma UNI 9502 “Procedimento analitico
per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso”. Per
semplificare ulteriormente il calcolo, in Appendice A alla suddetta norma UNI
si riporta la verifica della capacità portante con il metodo tabellare
semplificato. Tale verifica consiste nel determinare la distanza a dell’asse dell’acciaio dalla
superficie esposta al fuoco in funzione del tempo di esposizione
all’incendio, del tipo di acciaio nonché tenendo conto dei lati della
struttura esposti all’azione dell’incendio (Tabella 8). Determinato il valore
di a sarà possibile definire lo
spessore di copriferro minimo da garantire per la protezione dell’acciaio
ricorrendo alla seguente espressione:
dove: · cmin,f
= copriferro minimo per garantire la resistenza al fuoco; · f/2 = raggio equivalente dell’armatura
principale più esterna alla superficie.
Tabella 8 – Distanze a (cm), dell'asse dell'acciaio dalla superficie
esposta al fuoco Per poter
utilizzare correttamente i valori di a
riportati nella Tabella 8 è necessario tenere presente le seguenti ipotesi · i tassi di sollecitazione dell'acciaio nel
calcolo a freddo sono i massimi consentiti per il tipo di acciaio cioè σ
reale / σ max = 1 · la capacità portante dell'elemento dipende
dall'acciaio e non dal conglomerato cementizio · si considera il conglomerato cementizio
privo di acqua interna · si assume: 1) Fattore di riduzione in caso di incendio
delle azioni assunte a temperatura ordinaria ηfi = 0,7 2) Rapporto tra il coefficiente parziale di
sicurezza per l’acciaio in caso d’incendio e non gM,fi/gM =
1/1.15 per acciai controllati si ha
così: 3) Fattore di riduzione per la valutazione
della resistenza alla temperatura critica kcrit = 0.70 · 1/1.15 = 0.60 uguagliando kcrit con
kθ si individuano per i vari tipi di acciaio una temperatura
detta temperatura critica. θs1 crit. = 505 °C θs2 crit. = 440 °C θb crit. = 400 °C θp crit. = 350 °C I valori
di a riportati nella Tabella 8 sono
quelli dell’acciaio alla temperatura critica. La verifica che la distanza a per tutte le armature dimensionate
con il calcolo a freddo sia uguale o maggiore di quella riportata in Tabella
8 è condizione sufficiente a garantire la capacità portante dell'elemento
costruttivo, sempre che si possa escludere una minor capacità per riduzione
di resistenza del conglomerato cementizio. 5.
Casi particolari per copriferro minimo
Nella
scelta del valore del copriferro, inoltre, bisogna tener conto di alcune
considerazioni aggiuntive (Tabella 9) nel caso si debba realizzare: 1. Getto su un precedente getto di calcestruzzo 2. Superficie esterna del calcestruzzo irregolare 3. Calcestruzzo soggetto a fenomeni abrasivi
Tabella 9 – Prescrizioni aggiuntive nel
calcolo del copriferro 6.
Tolleranza di esecuzione relativa al copriferro (Dcdev)
Scelto il valore massimo tra
i copriferri minimi atti a garantire i requisiti sia di aderenza, durabilità,
resistenza al fuoco che di esecuzione, è necessario calcolare i valori della tolleranza - Dcdev
- per definire il valore del copriferro
nominale da inserire in capitolato, da riportare negli elaborati grafici
e da utilizzare nei calcoli statici. La scelta di Dcdev
deve essere effettuata in funzione della severità dei controlli e dei tipi di
getti che si realizzano in accordo con quanto definito dall’Eurocodice 2
(Figura 2).
Figura 2 –
Indicazioni per la scelta della tolleranza Si ricorda
che il draft dell’Appendice nazionale
Italiana per la norma UNI EN 1992-1-1 consiglia di fissare la tolleranza Dcdev = 10
mm, in
quanto molto spesso durante l’esecuzione e la messa in opera dei materiali,
pur impiegando accorgimenti e controlli, non è possibile garantire un
controllo preciso e puntuale del valore del copriferro reale. 7.
Copriferro nominale cNOM
A
seguito, quindi, delle considerazioni sopra riportate in merito alla
durabilità, resistenza al fuoco e trasmissione degli sforzi di aderenza tra
acciaio e calcestruzzo, nonché al soddisfacimento della vita nominale imposta
per la struttura e tenendo, infine, conto delle tolleranze di esecuzione si
potrà procedere alla definizione del copriferro nominale. E’ importante
ribadire quanto già evidenziato nell’introduzione al presente articolo che il
valore del copriferro nominale, in accordo alla definizione data sia dalle
NTC (D.M. 14.01.2008) che dagli Eurocodici, rappresenta la porzione netta di
calcestruzzo a ricoprimento delle armature sia esse longitudinali che staffe.
Il copriferro nominale, quindi, in nessun caso può essere confuso con la
distanza (d) del baricentro dell’armatura principale dalla superficie esterna
dell’elemento che viene impiegata nel dimensionamento strutturale degli
elementi in c.a. Il valore di d potrà essere opportunamente calcolato a
partire dal copriferro nominale cui bisognerà aggiungere il diametro delle
staffe e il semidiametro dell’armatura principale resistente (Figura 3):
Figura 3 – Differenza tra copriferro
nominale cNOM e distanza d
(d = cNOM + fSTAFFE + f/2BARRE) 8.
Accorgimenti ulteriori :armatura di pelle del copriferro
Come ultima notazione relativamente al
copriferro val la pena ricordare che quando lo spessore nominale dovesse
risultare maggiore o uguale di 60 mm (copriferro minimo 50 mm + 10 mm di
tolleranza), al fine di limitare l’ampiezza delle lesioni sempre possibili
nel calcestruzzo, è opportuno ricorrere ad una specifica armatura di pelle in
forma di rete elettrosaldata soprattutto quando l’armatura secondaria si
presenta diradata con passo superiore a 30 cm. Reti elettrosaldate di
diametro 6 mm e maglia 15x15 o 20x20 cm preferibilmente in acciaio nero (per
elementi strutturali interni, interrati o permanente immersi in acque
potabili), in acciaio zincato (per strutture aeree esposte al rischio di
corrosione da carbonatazione) o zincato (per strutture soggette all’azione de
passivante del cloruro) sono sufficienti allo scopo. 9.
Esempio riassuntivo (1) per il calcolo del copriferro
Si calcoli il copriferro per una trave di
calcestruzzo armato in classe di esposizione XC1 con i seguenti requisiti: · Calcestruzzo con
classe di resistenza C25/30 · Barre longitudinali
inferiori di armatura sono 4f20; le staffe
sono f8 con passo di
100 mm · Dimensione
massima degli aggregati: Dmax = 32mm · Vita nominale di
progetto della struttura: 50 anni · Controllo in
opera del copriferro normale · Resistenza al
fuoco su un lato per un tempo di esposizione pari a 90 min Sono rispettati i
requisiti di durabilità in accordo al prospetto 4 della norma UNI 11104 per
la classe di esposizione fissata. La classe strutturale dell’elemento in
esame è S4. 1.
CALCOLO DEL COPRIFERRO DELLE STAFFE
2.
CALCOLO DEL COPRIFERRO DELLE BARRE
Si nota che prevale il valore del
copriferro delle staffe, per cui il copriferro delle barre longitudinali
sarà: cNOM = 33 mm cNOM,barre = cNOM + fstaffe = 33 + 8 = 41 mm Il valore da riportare negli elaborate
grafici e utilizzare nel calcolo dimensionale, calcolato come somma del
copriferro nominale delle barre più raggio dell’armatura longitudinale: d = cNOM,barre + f/2barre
= 41 + 20/2 = 51 mm 10.
Esempio riassuntivo (2) per il calcolo del copriferro
Si calcoli il copriferro per una trave di
calcestruzzo armato di un pontile a contatto diretto con acqua di mare in
classe di esposizione XC4 – XS3 con i seguenti requisiti: · Calcestruzzo con
classe di resistenza C35/45 · Cemento CEM III/B
42.5 R · Barre
longitudinali inferiori di armatura sono 4f24; le staffe sono f8 con passo 100
mm · Dimensione
massima degli aggregati: Dmax = 20 mm · Vita nominale di
progetto della struttura: 100 anni · Controllo in opera
del copriferro normale Sono rispettati i
requisiti di durabilità in accordo al prospetto 4 della norma UNI 11104 per
le classi di esposizione fissate. 1.
CALCOLO DEL COPRIFERRO DELLE STAFFE
2.
CALCOLO DEL COPRIFERRO DELLE BARRE
Si nota che prevale il valore del
copriferro delle staffe. Pertanto il copriferro nominale risulta: cNOM
= 65 mm Il copriferro delle barre longitudinali,
invece, risulta: cNOM,barre = cNOM + fstaffe = 65 + 8 = 73 mm Il valore da riportare negli elaborate
grafici e utilizzare nel calcolo dimensionale, calcolato come somma del
copriferro nominale delle barre più raggio dell’armatura longitudinale: d = cNOM,barre
+ f/2barre = 73 + 24/2
= 85 mm Si ricorda che in questo caso, visto che lo
spessore nominale è maggiore di 60 mm, al fine di limitare l’ampiezza delle
lesioni, è opportuno inserire costituita da una rete elettrosaldata in
acciaio inossidabile di diametro 6 mm e maglia 15x 15 cm. 11. Bibliografia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ingegneriastrutturale.net -
Tutti i Diritti Riservati |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||