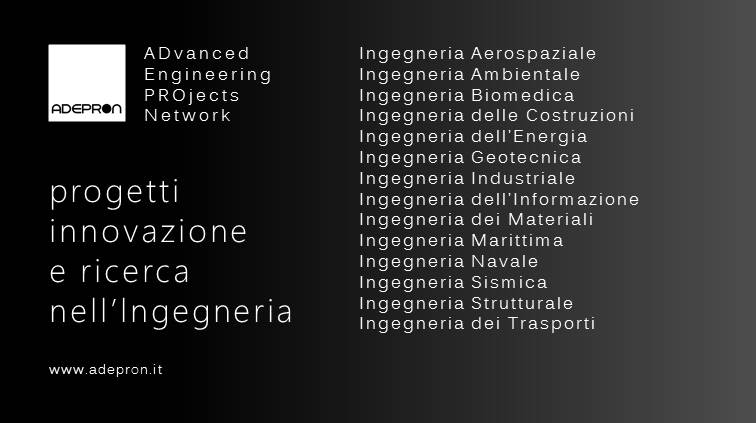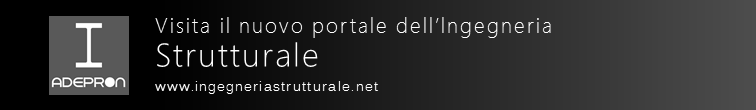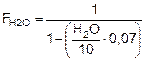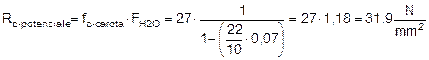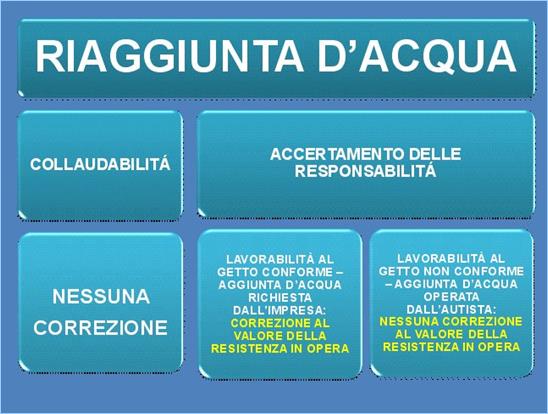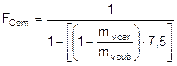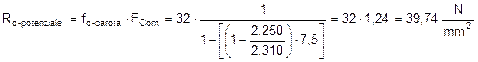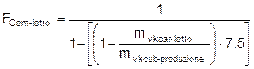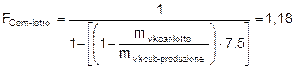|
· Normativa e Sicurezza
Strutturale · Norme Tecniche per le Costruzioni · · LA VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO · IN OPERA PER IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE E L’ACCERTAMENTO · DELLE RESPONSABILITÁ
DELL’IMPRESA E DEL PRODUTTORE · Luigi Coppola Alessandra Buoso · · INTRODUZIONE · · Come determinare la resistenza cubica in opera ai fini
della collaudabilità DELLA STRUTTURA:
· modalità di prelievo, tipologia e dimensioni delle
carote, numero minimo di carote · · Accertamento delle
responsabilità eventuali del fornitore del conglomerato · per non conformità della
resistenza a compressione cubica in opera
·
· Calcolo della resistenza cubica potenziale ai
fini
· dell’accertamento delle responsabilità del
produttore Introduzione Una delle
novità salienti introdotte dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni” emanate
ai sensi della Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e della Legge n. 64 del 2
Febbraio 1974 con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, pubblicato sul
Supplemento Ordinario n.30 della G.U. del 04 Febbraio 2008 è relativa
(paragrafo 11.2.6) al valore medio della resistenza
strutturale (Rcm-opera), misurata con tecniche opportune
(distruttive e non distruttive) e debitamente trasformata in resistenza
cilindrica o cubica, non inferiore all’85% del valore medio definito in fase
di progetto (Rcm). Si evidenzia, in particolare, come sia sempre possibile risalire alle responsabilità di eventuali non conformità (dei valori di resistenza a compressione misurati sui cubetti prelevati a bocca di betoniera o del valore della resistenza a compressione media in opera) quando la Direzione Lavori correttamente effettua i controlli di accettazione al momento della consegna del calcestruzzo in cantiere procedendo al confezionamento, alla conservazione e alla maturazione dei provini cubici in accordo alle norme UNI EN 12390 parte 1-2-3-4 e successivamente decida di effettuare anche il controllo della resistenza in opera mediante il prelievo delle carote (con rapporto h/d=1 in accordo alla norma EN 12504-1). In sostanza, la resistenza a compressione valutata sui cubetti a bocca di betoniera consente di stabilire se essa è conforme al valore caratteristico utilizzato dal progettista nel dimensionamento strutturale (valenza strutturale) permettendo, nell’eventualità che il controllo dovesse risultare negativo, di accollare gli oneri derivanti da una minore resistenza a compressione del calcestruzzo fornito rispetto a quella utilizzata per il calcolo strutturale (e pattuita nel contratto commerciale tra produttore e impresa), interamente al fornitore. Generalmente questi oneri possono essere stabiliti come segue:
Nel caso di un controllo di accettazione negativo, ma
anche allorquando il Direttore Lavori di fronte ad un controllo di
accettazione positivo nutre dubbi sulla qualità delle operazioni di posa in
opera, compattazione e maturazione dei getti si può disporre la valutazione
della resistenza a compressione in opera per stabilire se il valore è in
accordo con quanto stabilito al paragrafo 11.2.6 Norme Tecniche per le
Costruzioni. Nella eventualità che (Tabella 1):
In definitiva, quindi, se correttamente e in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni, il Direttore Lavori effettua i controlli di accettazione e successivamente decida di valutare la resistenza a compressione del calcestruzzo in opera sarà sempre possibile stabilire univocamente e con dati oggettivi le azioni da intraprendere e a chi accollare gli oneri derivanti dagli interventi che si rende necessario attuare.
Tabella 1– Casistiche possibili nella accertamento
della resistenza a compressione del calcestruzzo a bocca di betoniera e del
calcestruzzo in opera La situazione, invece, diventa più complicata in quei
contesti in cui la direzione lavori omette di effettuare i controlli di
accettazione non procedendo al prelievo del calcestruzzo e al confezionamento
dei cubetti prima di eseguire il getto, contravvenendo già ad un obbligo di
Legge, e successivamente decida di valutare la resistenza del calcestruzzo
dalle strutture in opera. Occorre tener presente, infatti, che la
determinazione del valore della resistenza a compressione in opera del
calcestruzzo ha, al pari del controllo di accettazione effettuato mediante il
prelievo dei cubetti a “bocca di betoniera”, una duplice valenza: da una
parte quella propriamente strutturale tesa a stabilire la collaudabilità
dell’elemento strutturale sul quale vengono effettuati i carotaggi e la
successiva determinazione della resistenza in opera. Dall’altra, la
valutazione della resistenza in opera si pone anche l’obiettivo di accertare,
di fronte ad un esito negativo del controllo, le responsabilità delle figure
coinvolte con particolare riferimento al produttore del calcestruzzo
(responsabile della qualità del conglomerato fornito) e all’impresa
esecutrice delle opere (sotto la cui responsabilità ricadono le operazioni di
posa, compattazione e maturazione dei getti). In sostanza, se il valore della
resistenza cubica media in opera (Rcm-opera)
dovesse risultare inferiore all’85% del valore della resistenza media Rcm-progetto utilizzata
per il dimensionamento strutturale tanto da richiedere per le strutture
coinvolte dalla non conformità interventi di consolidamento o di
demolizione/ricostruzione, si rende necessario stabilire chi tra produttore
del calcestruzzo e impresa esecutrice deve accollarsi gli oneri per questi
interventi suppletivi. Il presente articolo è dedicato a questa tematica e si
prefigge l’obiettivo di fornire una metodologia pratica per la determinazione
della resistenza in opera finalizzata ad accertare sia la collaudabilità
della struttura che le responsabilità di eventuali non conformità da parte
dei soggetti coinvolti (fornitore di calcestruzzo e impresa esecutrice). Come
determinare la resistenza cubica in opera ai fini della collaudabilità della
struttura: modalità di prelievo, tipologia e dimensioni delle carote, numero
minimo di carote Di seguito vengono riportate alcune indicazioni di
carattere pratico per la valutazione della resistenza a compressione cubica
del calcestruzzo in opera. Geometria delle carote:
diametro e snellezza della carota
Come è noto il dimensionamento delle sezioni in
calcestruzzo armato avviene sulla base del valore della resistenza
caratteristica a compressione misurata su provini cubici di lato 150
mm, compattati a rifiuto e maturati per 28 giorni alla temperatura
di 20±2°C e U.R. > 95%. Nella valutazione della resistenza a compressione
in opera essendo praticamente impossibile estrarre dalle strutture dei cubi
di lato 150 mm si deve ricorrere, invece, ad effettuare la prova di
schiacciamento su carote. Il valore della resistenza a compressione misurato
sulle carote dipende sensibilmente dalla geometria della stessa: ad esempio,
esso diminuisce all’aumentare del rapporto altezza/diametro. Pertanto, si
pone immediatamente il problema di quale devono essere la geometria e le
dimensioni della carota per far si che il valore della resistenza a
compressione misurato sia paragonabile a quello che si otterrebbe con lo
stesso calcestruzzo (e nelle stesse condizioni di compattazione e con le
medesime modalità di stagionatura) qualora la prova di schiacciamento venisse
effettuata utilizzando un provino cubico. Innanzitutto occorre precisare che il valore della
resistenza a compressione è influenzato dal rapporto tra il diametro della
carota (d) e la dimensione massima dell’aggregato utilizzato nel
confezionamento dell’impasto (Dmax). Questa influenza diventa
significativa quando d/Dmax risulta inferiore a 3. Pertanto, tenendo
presente che generalmente i calcestruzzi vengono confezionati con aggregati
aventi Dmax pari a 32 mm è opportuno che il diametro delle carote
risulti almeno di 100 mm. Inoltre, la resistenza a compressione è influenzata
dalla snellezza della carota e, quindi, dal rapporto tra altezza e diametro.
In accordo con la norma EN 13791 la resistenza a compressione misurata su
carote con diametro 100 mm e rapporto h/d=1 è assimilabile a quella misurata
proprio sul provino cubico di lato 150 mm (nelle stesse condizioni di
compattazione e con le stesse modalità di stagionatura). Pertanto, si può
concludere che relativamente alla geometria della carota le prove di
schiacciamento debbono essere effettuate su carote con: - diametro 100 mm - rapporto h/d=1 Quindi, a meno che non esistano particolari esigenze
derivanti: · dal dover valutare la resistenza di un
calcestruzzo confezionato con aggregati aventi Dmax superiore a 32
mm (ad esempio 40 mm), allorquando potrebbe essere opportuno ricorrere a
carote di diametro 150 mm e altezza 150 mm (in modo da lasciare invariata la
snellezza); · dalla impossibilità di prelevare carote
prive di ferri d’armatura paralleli all’asse longitudinale della carota,
allorquando potrebbe essere necessario ricorrere all’estrazione di una carota
con diametro inferiore a 100 mm (ad esempio 75 mm), ma mai inferiore a 50 mm, è opportuno attenersi, relativamente alla geometria della carota, alle disposizioni sopra riportate in quanto l’adozione di carote con diametri diversi da 100 mm impone l’applicazione di un coefficiente correttivo non sempre di facile individuazione. Si tenga conto in proposito che la resistenza a compressione sulle carote con diametro 100 mm (a parità di rapporto h/d) può risultare maggiore di quella determinata su carote di diametro 50 mm di un valore che oscilla tra il 7 e il 27% a seconda che la dimensione massima dell’aggregato sia di 20 oppure di 40 mm rispettivamente. Come si può intuire la variazione subita dalla resistenza a compressione al variare del diametro della carota rispetto a quella misurata sulla carota da 100 mm, che è direttamente assimilabile alla resistenza cubica, è abbastanza consistente. Pertanto, a meno che non esista una reale necessità, alla luce della difficoltà di individuare con esattezza il fattore correttivo da applicare si suggerisce di utilizzare carote con diametro pari a 100 mm. Ovviamente non esiste alcuna necessità di adottare carote con rapporti h/d > 1. Pertanto, durante il procedimento di preparazione del campione si procederà a tagliare la carota in modo da ottenere il rapporto h/d=1. Se l’estrazione avviene da elementi che per il ridotto spessore o per la scadente qualità del calcestruzzo non consentono di ottenere carote con rapporto h/d=1 al valore della resistenza a compressione occorrerà apportare una correzione che tenga conto della minore snellezza del provino (Tabella 2). Come si può notare il fattore di correzione è influenzato anche dal livello di resistenza a compressione del calcestruzzo.
Tabella
2 – Coefficiente correttivo della resistenza a compressione (Fh/d)
misurata su carote con rapporto h/d diverso da 1 per la trasformazione nella
corrispondente resistenza a compressione cubica Pertanto, se ad esempio è stata determinata una
resistenza a compressione di 20 N/mm2 su una carota di diametro
100 mm e rapporto h/d = 0.75 la resistenza a compressione sulla carota con
rapporto h/d=1 e d =100 mm vale: Rc-opera =
fc-carota · Fh/d = 20 · 0.83 = 16.6 N/mm2 Taglio, rettifica e spianatura
della carota
Nell’esecuzione delle operazioni di carotaggio
l’utensile dovrà essere fissato rigidamente alla struttura in calcestruzzo mediante
degli opportuni tasselli al fine di garantire che l’asse della carota risulti
perfettamente verticale. Dopo il taglio meccanico per ottenere, come
suggerito al paragrafo precedente una carota di snellezza h/d=1, si procederà
all’operazione di spianatura e rettifica delle basi del provino con macchina
provvista di mole abrasive. Questa modalità di rettifica delle carote è da
preferirsi a quella che utilizza malte a presa rapida applicate in spessore
sottile sulle basi delle carote. Questo per riprodurre le stesse condizioni
di prova esistenti nella rottura a compressione dei cubetti i quali vengono
posti con le basi direttamente a contatto con la superficie dei piatti della
pressa. Pertanto, nella prova di schiacciamento della carota per riprodurre la
stessa situazione che si ha nella rottura del provino cubico è opportuno non
interporre alcuno strato di materiale aggiuntivo tra i piatti della macchina
e le basi della carota da sottoporre a prova. Nell’eventualità si volesse
ricorrere alla rettifica con strato di malta (in gergo definita “cappatura”)
è assolutamente sconsigliabile utilizzare malte di bassa resistenza e basso
modulo elastico, quali ad esempio, le malte a base di gesso. Infatti, in
questa evenienza si ridurrebbe l’effetto di confinamento esercitato dai
piatti della pressa sul calcestruzzo con il risultato che la resistenza a
compressione misurata sul provino “cappato” risulterebbe inferiore a quella
misurata sullo stesso provino rettificato meccanicamente. In conclusione,
quindi, si suggerisce di effettuare la rettifica delle carote con
procedimento meccanico. È opportuno far presente che al fine di limitare
l’influenza derivante da una non corretta maturazione dei getti (che
fortunatamente ha scarse implicazioni sugli aspetti relativi alla
collaudabilità dell’opera, ma incide pesantemente sulla durabilità delle
strutture) è opportuno quando si effettua il taglio della carota che vengano
rimossi i primi 2,5 ÷ 3cm più corticali che sono quelli interessati da un
minor grado di idratazione. Presenza di ferri d’armatura
Prima di effettuare il carotaggio è opportuno dotarsi
di un magnetometro (pacometro o profometro) per individuare le zone della
struttura dove poter effettuare un carotaggio senza interessare le barre di armatura.
Innanzitutto occorre evidenziare che non è possibile utilizzare carote che
presentino ferri paralleli all’asse longitudinale della stessa in quanto il
valore misurato della resistenza a compressione sarebbe fortemente
influenzato dalla presenza del tondino. Carote con ferri disposti
perpendicolarmente all’asse longitudinale possono essere impiegate nella
prova di schiacciamento, ma il valore misurato deve essere opportunamente
incrementato per tener conto dell’effetto di disturbo dovuto alla presenza
del ferro. In linea di massima l’incremento deve essere tanto maggiore quanto
maggiore è il rapporto tra diametro del tondino e quello della carota e
quanto più esso dista dalle basi della carota stessa. Il coefficiente
correttivo (FFe) può
essere desunto dall’espressione riportata nel Rapporto Tecnico n.11 della
Concrete Society:
dove: - Φ è il diametro del tondino in mm - d è il diametro della
carota in mm - d’ è la distanza del tondo
dalla base più vicina della carota in mm - h è l’altezza della carota
in mm. Quindi, se ad esempio la
resistenza a compressione misurata su una carota con rapporto h/d=1 e d=100
mm contenente un tondino di diametro pari a 14 mm posto ad una distanza di 30
mm dalla base della carota è risultata di 25 N/mm2, la resistenza
a compressione misurata su una carota priva di ferro sarebbe risultata pari
a: Rc-opera =
fc-carota · FFe = 25 · (1 +
(1,5·(14/100)·(30/100))) = 25 · 1.063 = 26.6 N/mm2. L’effetto derivante dalla
presenza del tondino, nel caso in esame, conduce ad apportare un incremento
al valore della resistenza misurato di circa il 6%. Ovviamente, nel caso di
carota priva di ferri il coefficiente correttivo FFe = 1. Effetto derivante dall’azione
del carotiere: il tormento
Durante l’esecuzione del
carotaggio occorre ridurre al minimo gli effetti torsionali che l’utensile
provoca sulla struttura in calcestruzzo. Per questo motivo, come già in
precedenza suggerito occorre fissare rigidamente il carotiere alla struttura
per evitare il suo asse subisca oscillazioni durante l’operazione di
estrazione della carota. Anche fissando saldamente l’utensile, tuttavia,
l’operazione di carotaggio non è “indolore” per il calcestruzzo in quanto può
determinare la comparsa di microlesioni interne tanto più accentuate quanto
più scadente è la qualità del calcestruzzo in opera. Pertanto, di questo
effetto (definito di “tormento”) si deve tener conto incrementando la
resistenza a compressione misurata sulla carota di un fattore FTor
inversamente proporzionale alla resistenza del conglomerato (Tabella 3).
Tabella 3 – Coefficiente correttivo (FTor)
della resistenza a compressione della carota per tener conto dell’effetto
derivante dal “tormento” dell’utensile Pertanto, se ad esempio, la resistenza a compressione misurata
su una carota con rapporto h/d=1 e diametro 100 mm, priva di ferri, è
risultata di 25 N/mm2 la resistenza a compressione determinata su
un provino di calcestruzzo non sottoposto a carotaggio, confezionato e
maturato in identiche condizioni, sarebbe del 10% più elevata e, quindi pari
a 27.5 N/mm2 (25 · 1.10). Effetto dovuto alla direzione
del carotaggio rispetto a quella di getto
Il carotaggio effettuato in
direzione perpendicolare a quella di getto intercetta microfessurazioni che
durante la prova di schiacciamento si dispongono parallelamente alle
isostatiche di compressione favorendo la rottura per valori dello sforzo
inferiori a quelle che si registrano per la stessa carota prelevata
parallelamente alla direzione di getto. La penalizzazione della resistenza
per effetto di un carotaggio perpendicolare alla direzione di getto risulta
tanto più marcata quanto più il prelievo viene effettuato verso le zone
sommitali del getto che sono maggiormente interessate dal fenomeno di
bleeding e quindi presentano un livello di microfessurazione interna più
accentuato rispetto a quello che interessa le zone basali della struttura. In
accordo con la EN 13791, pertanto, il valore della resistenza a compressione
misurato sulle carote estratte dalla struttura deve tener conto della
direzione del carotaggio. In linea di massima per le carote prelevate
parallelamente alla direzione di getto, come avviene nei pavimenti o nelle
platee di fondazione, non occorre apportare alcuna correzione al valore della
resistenza misurata sulle carote, per le quali l’effetto delle
microfessurazioni interne è poco influente nella prova di schiacciamento. Per
contro, la resistenza a compressione misurata sulle carote prelevate in
direzione perpendicolare al getto, come avviene quando si effettua il
carotaggio su un pilastro oppure un muro di sostegno, deve essere
opportunamente incrementato attraverso un coefficiente di correzione (FDir)
che tenga conto anche della posizione del prelievo se alla base, cioè, in una
zona intermedia, oppure in testa alla struttura (Tabella 4).
Tabella 4 – Coefficiente correttivo per tener conto della
direzione del carotaggio rispetto a quella di posa in opera del conglomerato
(h indica l’altezza dell’elemento verticale) Quindi, se ad esempio, la resistenza a compressione
misurata su una carota con rapporto h/d=1 e d=100mm prelevata al centro di un
pilastro è risultata di 30 N/mm2 occorre incrementare il valore
della resistenza a compressione per tener conto del fatto che la carota è
stata prelevata perpendicolarmente alla direzione di getto. Il valore
corretto della resistenza della carota risulta pertanto pari a 32.3 N/mm2
(30 · 1.075). Effetto dell’età della carota e
della temperatura di maturazione in cantiere
La Rck utilizzata per il calcolo
strutturale, come è ben noto, si intende misurata su provini maturati per 28 giorni
alla temperatura di 20±2°C. É difficile, invece, che l’età della carota al
momento in cui la stessa viene sottoposta alla prova di schiacciamento
coincida con i 28 giorni. Basti pensare al fatto che, generalmente, si
procede alla valutazione della resistenza in opera allorquando è ormai noto
l’esito (negativo) del controllo di accettazione dei provini confezionati a
“bocca di betoniera” e, quindi, quando ormai è trascorso un tempo
dall’esecuzione del getto superiore ad un mese. A volte, si decide di effettuare
la valutazione della resistenza in opera quando i getti palesano evidenti
difettosità con calcestruzzo pulverulento o incoerente. Generalmente in
questi casi si procede al carotaggio senza attendere preliminarmente i dati
delle prove di schiacciamento relative al controllo di accettazione a bocca
di betoniera. É ben noto, che la resistenza a compressione del
calcestruzzo cresce nel tempo, sebbene nei primi giorni la velocità di
sviluppo è maggiore e va man mano attenuandosi alle lunghe stagionature.
Pertanto, se le prove di schiacciamento avvenissero su carote di età molto
giovane il valore misurato sarebbe sottostimato rispetto a quello che il
calcestruzzo potrebbe attingere all’età di 28 giorni. Pertanto, al valore
misurato della resistenza a compressione di una carota di età generica t inferiore a 28 giorni occorrerà
apportare una correzione (incremento) per tener conto del fatto che il
conglomerato ha una ulteriore riserva di resistenza da sviluppare. Se le
prove di schiacciamento vengono effettuate su carote di età maggiore dei 28
giorni ovviamente il valore della resistenza sviluppato sarà maggiore di
quello che il conglomerato possedeva all’età di 28 giorni. Tuttavia, in
questa seconda situazione è poco importante ai fini della collaudabilità che
la resistenza a compressione a 28 giorni era inferiore a quella misurata
sulle carote di età superiore. Pertanto, in questa evenienza al valore
misurato della resistenza a compressione della carota di età maggiore di 28
giorni non occorre apportare alcuna correzione (decremento). In definitiva
per tener conto dell’età del calcestruzzo al momento dell’esecuzione della
prova di schiacciamento la correzione potrà essere effettuata utilizzando la
formula dell’Eurocodice che esprime la resistenza a compressione ad un tempo
generico t, fc(t), in funzione di quella a 28 giorni, fc28:
dove: - t è il tempo
a cui si effettua il carotaggio (t < 28gg) - s è una costante funzione
del tipo di cemento impiegato
Ai fini della collaudabilità della struttura si
assumerà: · Ft=1 per carote sottoposte a compressione ad
età maggiori di 28 giorni (t >
28gg); · Ft = 1/exp[s[1-(28/t)1/2]] per carote
sottoposte a compressione ad età inferiori a 28 giorni (t
< 28gg). Si supponga, a titolo di esempio, che una carota di
calcestruzzo, confezionato con cemento CEM II/A-L 42.5R, venga sottoposta a
schiacciamento dopo 7 giorni dal getto ed evidenzia a questa età una
resistenza a compressione di 16 N/mm2. Ai fini della
collaudabilità si potrà fare affidamento su una resistenza a compressione
maggiore che il conglomerato svilupperà nei giorni successivi che potrà così
essere quantificata: 16 · Ft = 16 · (1/exp[-0.2]) = 16 · 1.22 =
19.5 N/mm2. Se, invece, la stessa carota fosse stata sottoposta
alla prova di schiacciamento dopo 60 giorni evidenziando un valore di
resistenza a compressione di 35 N/mm2 esso risulterebbe superiore
alla resistenza che il conglomerato avrebbe evidenziato a 28 giorni di circa
il 6% (Rc-carota28gg = 35 · (1/exp[0.063]) = 35 · 0.94 = 32.9 N/mm2),
ma ai fini della collaudabilità questa correzione non si rende necessaria
adottando il valore della resistenza effettivamente ottenuta nella prova di
schiacciamento e pari a 35 N/mm2 (Ft=1). Oltre all’età della carota al momento dello
schiacciamento si deve tener conto anche della temperatura a cui è maturato
il calcestruzzo della struttura in opera. Infatti, se la determinazione della
resistenza avviene su una carota estratta da una struttura realizzata durante
il periodo invernale che in cantiere è maturata a temperature inferiori a
20±2°C è evidente che il valore della resistenza a compressione è
sottostimato rispetto a quella che lo stesso calcestruzzo avrebbe evidenziato
a 20°C. In questo caso del più lento sviluppo della resistenza a compressione
si deve tener conto incrementando il valore determinato nella prova di
schiacciamento in quanto alle lunghe stagionature il conglomerato potrà
recuperare il deficit di resistenza che evidenzia qualora la rottura della
carota avvenga a tempi brevi dall’esecuzione del getto. Per contro, per le
strutture realizzate nel periodo estivo si deve tener conto che la
maturazione del calcestruzzo a temperature più elevate favorisce un più
rapido sviluppo di resistenza. Soprattutto se la valutazione della resistenza
a compressione viene effettuato su carote di età inferiore a 28 giorni si
deve tener conto del più rapido sviluppo della resistenza (riducendo il
valore effettivo misurato) altrimenti si incorre in una sovrastima della
resistenza a compressione a 28 giorni. La correzione dei valori di resistenza
misurati sulle carote per tener conto di temperature di maturazione in
cantiere diverse da 20°C si effettua calcolando la media ponderale della
temperatura ambientale dal momento dell’esecuzione dei getti e sino al giorno
in cui viene effettuato il carotaggio. Questi dati possono essere ricavati
consultando le pagine web dell’aeroporto più vicino al cantiere oppure quelle
dell’Agenzie Regionale Per l’Ambiente (ARPA). Calcolata la temperatura media
ponderale, si può applicare la correzione al valore della resistenza
determinata sulla carota estratta dalla struttura dividendolo per il
coefficiente correttivo FT
desunto dalla Tabella 5, con le seguenti limitazioni:
T > 22°C e FT >1
→ FT = 1; T < 18°C e FT < 1 → FT
= 1
Tabella
5 – Coefficiente correttivo per tener conto di temperature di maturazione
delle strutture in cantiere diverse da 20°C Calcolo della resistenza cubica
in opera ai fini della collaudabilità della struttura
In definitiva, riassumendo tutte le considerazioni
contenute ai precedenti paragrafi si può scrivere la formula più generale per il calcolo della resistenza cubica del
calcestruzzo in opera valida ai fini della collaudabilità:
dove:
Esempio di calcolo della
resistenza cubica in opera per stabilire la collaudabilità della struttura
Si supponga di aver estratto da un muro di sostegno
alto 5 m una carota di calcestruzzo (confezionato con un cemento di classe
32.5N) in una zona della struttura posta a 0.5 m dalla sommità del muro dove
la struttura è meno impegnata dal punto di vista statico. L’estrazione della
carota di diametro pari a 100 mm avviene dopo 3 giorni dal getto avvenuto
durante il periodo estivo quando la temperatura media ponderale esistente in
cantiere è di 30°C. Per la particolare densità dei ferri d’armatura la carota
estratta presenta un tondino di diametro 12 mm perpendicolare all’asse
longitudinale della carota ad una distanza dalla base più vicina pari a 20
mm. Il valore sperimentale della resistenza a compressione ottenuto
sottoponendo la carota dopo averla tagliata, rettificata e spianata
meccanicamente ottenendo per la stessa un’altezza di 75 mm, è risultato pari
a 18.5 N/mm2. In questo contesto abbiamo: - fc-carota
= 18.5
N/mm2; - Fh/d = 0.83 con h/d=0.75; - FFe
= 1.048
(vedi equazione [1]); - FTor = 1.12; - FDir = 1.10; - Ft = 1/(exp [0.38 [1-(28/3)1/2]]) = 2.18 ; - FT = 0.87. Pertanto, la resistenza cubica in opera vale (equazione
[3]): Rc-opera= fc-carote
· Fh/d · FFe · FTor
· FDir · Ft · FT =
18.5 · 0.83 · 1.2 · 1.12 · 1.10 · 2.18· 0.87 =
38.44N/mm2 Come si può notare, il valore della resistenza cubica
in opera ai fini della collaudabilità risulta decisamente maggiore di quello
sperimentale derivante dalla rottura a compressione della carota. Questo
risultato discende dal fatto che l’estrazione della carota è avvenuta dopo
appena 3 giorni e, quindi, il conglomerato possiede una riserva di resistenza
che svilupperà al 28-esimo giorno di quasi 22 N/mm2. Questa
riserva di resistenza risulta così elevata anche perché nel confezionamento
del conglomerato è stato impiegato un cemento di classe 32.5N che a 3 giorni
(al momento della rottura per schiacciamento) ha un grado di idratazione
basso che, successivamente, nei 25 giorni che lo separano dalla stagionatura
di 28 giorni, sarà maggiore di quello di un cemento ad indurimento rapido.
Conseguentemente il calcestruzzo subirà un maggior incremento della
resistenza a compressione nel tempo. É inutile sottolineare come se si
procedesse alla valutazione della collaudabilità della struttura sulla base
del valore “grezzo” della resistenza a compressione ottenuto dallo
schiacciamento della carota si commetterebbe un evidente errore sottostimando
pesantemente il valore effettivo della resistenza cubica in opera del
conglomerato. Criterio per stabilire la
collaudabilità della struttura: Norme Tecniche per le Costruzioni(D.M.
14/01/2008) e Norma Europea EN 13791
Chiarito ai paragrafi precedenti come effettuare il
calcolo della resistenza cubica in opera (Rc-opera) è opportuno
definire quale criterio adottare per stabilire la collaudabilità degli
elementi sottoposti ad indagine. Le possibilità almeno sulla carta sono due,
adottare il criterio: · stabilito dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni secondo il quale la struttura è collaudabile se la resistenza
cubica media in opera risulta almeno pari all’85% del valore medio della
resistenza a compressione di progetto (1).
· previsto dalla norma europea EN 13791 secondo la quale la
struttura è collaudabile se il valore caratteristico della resistenza cubica
in opera è almeno pari all’85% del valore caratteristico di progetto:
Il criterio previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni
risulta essere particolarmente stringente, si ritiene pertanto che la
collaudabilità della struttura dovrebbe essere verificata con il criterio
suggerito dalla norma europea EN 13791 (2).
In accordo con questa normativa, quindi, si rende necessario determinare il
valore caratteristico della resistenza a compressione in opera il quale può
essere calcolato ricorrendo a due approcci distinti quello A (statistico) e
quello B (forfetario). L’approccio
statistico si applica quando il numero di carote sottoposte a prova è almeno
pari a 15; in questo caso la resistenza caratteristica cubica in opera è il
valore minore desunto dalle due seguenti equazioni:
dove: - Rck-opera è la resistenza caratteristica
cubica del calcestruzzo in opera (in N/mm2); - Rcm-opera è il valore medio
delle resistenze cubiche in opera (in N/mm2); - sn-opera è lo scarto quadratico
medio dei valori delle resistenze cubiche in opera (in N/mm2), il
quale deve essere assunto almeno pari a 2 N/mm2; - Rcmin-opera è il valore minimo
delle resistenze cubiche in opera (in N/mm2). Adottando l’approccio di tipo B (forfetario) la resistenza
caratteristica cubica in opera è il valore minore desunto dalle due seguenti
equazioni:
dove i simboli hanno lo stesso significato
dell’equazioni [6] e [7] e K è un coefficiente che dipende dal numero di
carote (n) sottoposte alla prova di schiacciamento e può essere desunto dalla
Tabella 6.
Tabella 6 – Coefficiente K per la determinazione del
valore caratteristico della resistenza cubica a compressione del calcestruzzo
in opera Come si può notare, la normativa tende ad essere più premiante allorquando il lotto sottoposto a prova è costituito da un maggior numero di carote. Relativamente a quest’ultimo aspetto, il numero di carote da utilizzare, ovviamente, deve essere commisurato al volume di calcestruzzo degli elementi che si intende indagare. In linea di massima, e a puro titolo di suggerimento, si può operare come segue:
A questo punto il procedimento per l’accertamento della
collaudabilità della struttura può ritenersi concluso. E’ opportuno sin d’ora
ribadire come il procedimento sopra illustrato
può essere utilizzato esclusivamente per stabilire se la struttura è
collaudabile o meno e, quindi, per stabilire se occorre eventualmente
sottoporre gli elementi strutturali ad interventi di consolidamento oppure se
gli stessi debbono essere demoliti e ricostruiti ex-novo. Per nessun motivo, di fronte ad una
eventuale non conformità del valore della resistenza cubica in opera,
indipendentemente che si adotti il criterio di valutazione delle Norme
Tecniche o quello previsto dalla norma EN 13791, questa potrà essere attribuita al produttore del conglomerato.
Circa la valutazione di eventuali responsabilità del fornitore di
calcestruzzo occorrerà operare in accordo a quanto riportato nei paragrafi
che seguono. Accertamento delle responsabilità eventuali del fornitore del
conglomerato per non conformità della resistenza a compressione cubica in
opera Di fronte ad una non conformità della resistenza cubica in opera - mancato rispetto di una delle equazioni [4] o [5] in funzione del criterio di collaudabilità prescelto – esiste la necessità di stabilire se vi sono responsabilità da parte del fornitore di calcestruzzo. Questa necessità, ovviamente, non sussiste in quei contesti in cui la D.L. ha effettuato, come peraltro imposto dagli obblighi di legge, il “controllo di accettazione” del conglomerato. Infatti, attraverso la valutazione dei dati di resistenza a compressione misurati sui cubetti prelevati a “bocca di betoniera” – come più volte evidenziato – si può stabilire univocamente e in maniera oggettiva se il produttore ha fornito o meno il calcestruzzo con la resistenza caratteristica effettiva (Rckeff) conforme (cioè uguale o maggiore) a quella utilizzata nel progetto strutturale (Rckprogetto) e pattuita contrattualmente tra fornitore e impresa. Pertanto, si ribadisce l’estrema importanza di procedere all’effettuazione dei controlli di accettazione sui provini a “bocca di betoniera” per stabilire univocamente ed oggettivamente eventuali responsabilità del fornitore. In assenza di questi controlli - in presenza, quindi, di una omissione da parte della D. L. di un obbligo di legge – e quando la D. L. con un “ravvedimento postumo” decida di effettuare una verifica della resistenza cubica in opera che si riveli negativa esiste la necessità di stabilire se vi sono, relativamente al mancato rispetto dei requisiti di collaudabilità, eventuali responsabilità da parte del fornitore. L’accertamento di queste responsabilità non si rivela spesso né di facile, e soprattutto, né di univoca soluzione in quanto presenta non pochi elementi di soggettività, ma anche di difficile quantificazione. Pertanto, il procedimento descritto nel seguito vuole solo rappresentare un contributo a “dipanare” una questione – l’accertamento delle responsabilità del produttore attraverso l’analisi dei dati di resistenza a compressione determinati sulle carote estratte dalle strutture in opera – tra le più complesse che investono spesso il contenzioso relativo al mondo delle costruzioni in calcestruzzo armato. Il problema dell’accertamento delle responsabilità del
fornitore del conglomerato va affrontato in questi termini: tenendo presente
che la resistenza caratteristica effettiva del calcestruzzo fornito dal
produttore deve essere determinata su provini cubici di calcestruzzo
confezionati a “bocca di betoniera” compattati a rifiuto e maturati per 28
giorni alla temperatura di 20±2°C e U.R. > 95%, in assenza di questi dati
(si ribadisce per omissione da parte della D.L. di un obbligo di legge) se si
vuole accertare eventuali responsabilità da parte del produttore (sulla
mancata collaudabilità della struttura) esclusivamente attraverso le misure
di resistenza a compressione effettuate dalle carote estratte dal
calcestruzzo in opera, ci si deve chiedere “quale sarebbe stata la resistenza caratteristica a compressione del
calcestruzzo in opera se lo stesso fosse stato sottoposto a prove di
schiacciamento utilizzando provini cubici compattati a rifiuto, maturati alla
temperatura di 20°C e U.R. del 95% per 28 giorni??”. Questo valore della
resistenza a compressione nel prosieguo del presente articolo verrà
individuata dal termine resistenza
caratteristica cubica equivalente (Rck-potenziale).
Questa resistenza a compressione caratteristica non può essere confusa né con
quella cubica caratteristica in opera per la verifica della collaudabilità
della struttura (Rck-opera) né, a maggior ragione, con il valore
grezzo determinato dalla mera rottura di una (Rc-carota) o più
carote estratte dalla struttura. Alle modalità di determinazione della
resistenza caratteristica cubica potenziale (Rck-potenziale) sono
dedicati i paragrafi che seguono. Geometria della carota, taglio
e rettifica, presenza di ferri, tormento e direzione del carotaggio
Relativamente alle influenze della geometria della
carota (diametro e snellezza), alle operazioni di taglio, rettifica e
spianatura, alla presenza di ferri d’armatura, al tormento esercitato dal
carotiere e all’influenza della direzione del carotaggio rispetto a quelle di
getto sul valore della resistenza a compressione misurata sulla carota
estratta dalle strutture in opera continuano a valere tutte le considerazioni
già esplicitate nella sezione relativa al calcolo della Rc-opera
ai fini della collaudabilità. In sostanza, le influenze dei fattori
sopramenzionati incidono allo stesso modo sia che si debba procedere alla
valutazione della resistenza ai fini della collaudabilità che si debba
determinare la resistenza caratteristica cubica equivalente per accertare
eventuali responsabilità del fornitore. Pertanto, il valore della resistenza
a compressione determinato sperimentalmente su una carota con diametro pari a
100 mm (fc-carota(d=100mm)) anche nel caso della quantificazione
di Rc-potenziale verrà opportunamente corretto introducendo gli
stessi fattori di correzione Fh/d, FFe, FTor,
FDir già esplicitati a proposito del calcolo di Rc-opera.
Relativamente alle influenze della età della carota al momento della prova di
schiacciamento e alla temperatura di maturazione del calcestruzzo in opera,
invece, occorre introdurre alcune significative variazioni rispetto alle
considerazioni riportate nei paragrafi precedenti in merito alla
collaudabilità, presentate nei due paragrafi che seguono. Età della carota al momento
dell’esecuzione della prova di schiacciamento
Nel caso di accertamento della responsabilità del
produttore se la prova di schiacciamento viene effettuata su carote con età
inferiore a 28 giorni ci si comporterà allo stesso modo di quanto suggerito a
proposito della collaudabilità delle strutture. Quindi, il valore
sperimentale della resistenza a compressione verrà incrementato mediante il
coefficiente Ft desunto dall’equazione [2] per ottenere la
resistenza a compressione del calcestruzzo all’età di 28 giorni, stagionatura
alla quale vengono sottoposti a compressione i provini confezionati a bocca
di betoniera. Se le prove di schiacciamento vengono, invece, effettuate su
carote con età maggiore di 28 giorni, contrariamente a quanto illustrato per
la collaudabilità, il valore sperimentale della resistenza a compressione
misurato sulla carota dovrà essere ridotto attraverso il coefficiente Ft
(≠ 1) desunto dall’equazione [2] per tener conto che il conglomerato
alla stagionatura di 28 giorni (quella a cui vengono schiacciati i provini
confezionati a bocca di betoniera) aveva una resistenza inferiore. Pertanto,
se, ad esempio, il valore sperimentale della resistenza a compressione
misurato su una carota di calcestruzzo (confezionato con cemento di classe CEM
42.5R) con 60 giorni di età è risultato pari a 35 N/mm2, ai fini
dell’accertamento delle responsabilità questo valore andrà corretto per
tramutarlo in quello che il conglomerato avrebbe attinto a 28 giorni. La
correzione si effettua moltiplicando il valore sperimentale della resistenza
a compressione per il coefficiente Ft calcolato con l’equazione
[2] (Ft = 0.94): Rc-potenziale = 35 · 0.94 = 32.9 N/mm2.
In definitiva, quindi, per l’accertamento delle responsabilità del produttore
il coefficiente Ft, indipendentemente dall’età a cui avviene lo
schiacciamento della carota verrà desunto dall’equazione [2]. Temperatura di maturazione del
calcestruzzo in cantiere
I provini di calcestruzzo confezionati a bocca di
betoniera ai fini del controllo di accettazione vengono sottoposti alla prova
di schiacciamento dopo 28 giorni di maturazione alla temperatura di 20°C.
Pertanto, per il calcolo della resistenza cubica equivalente per
l’accertamento delle responsabilità del produttore il valore sperimentale
ottenuto dalle prove di schiacciamento della carota estratta dalla struttura
deve essere opportunamente corretto se la temperatura di maturazione del
calcestruzzo in cantiere è diversa da 20°C. Rispetto a quanto stabilito per
la collaudabilità della struttura, in questo caso la correzione deve essere
effettuata con i coefficienti desunti dalla Tabella 5 indipendentemente dalla
temperatura di maturazione e dall’età della carota al momento dell’esecuzione
della prova. In sostanza, rispetto a quanto riportato a proposito della
collaudabilità si opererà come segue:
In tutte le altre situazioni si opera come già
suggerito a proposito della collaudabilità. Pertanto, in definitiva per il
calcolo della resistenza a compressione cubica equivalente la correzione va
effettuata desumendo il coefficiente FT dalla Tabella 5
indipendentemente dalla temperatura e dall’età a cui la carota viene
sottoposta alla prova di compressione. Fattori aggiuntivi per il
calcolo della resistenza caratteristica a compressione equivalente
In sostanza, per quanto almeno sin qui detto, non ci
sono differenze significative tra il calcolo della resistenza cubica in opera
(Rc-opera) per la verifica
della collaudabilità della struttura e quello della resistenza cubica
potenziale per l’accertamento delle responsabilità del produttore (Rc-potenziale)
salvo una diversa modalità di quantificazione dei coefficienti correttivi che
tengono conto dell’influenza dell’età della carota al momento dell’esecuzione
della prova di schiacciamento (Ft) e della temperatura di
maturazione del calcestruzzo in cantiere (FT). Tuttavia, ci sono
dei fattori che influenzano pesantemente il valore della resistenza a
compressione equivalente che, invece, non riguardano il calcolo della
resistenza cubica in opera. Questi fattori sono relativi a: - le aggiunte di acqua in autobetoniera; - le modalità di posa in opera e
compattazione del calcestruzzo; - le procedure e alla durata della
maturazione umida delle strutture. All’approfondimento di queste influenze sono dedicati i
paragrafi che seguono. Le aggiunte di acqua in autobetoniera
Relativamente alle riaggiunte di acqua effettuate in autobetoniera, ai fini dell’accertamento delle responsabilità del produttore, occorre distinguere il caso in cui il calcestruzzo in cantiere:
Prima di procedere ad esaminare i due casi
sopramenzionati è opportuno sottolineare che ai fini della verifica della
collaudabilità della struttura (Figura 1) è
indifferente che l’aggiunta di acqua in autobetoniera avvenga nella
situazione a) oppure b). Infatti, la penalizzazione della resistenza a
compressione del conglomerato per effetto dell’aggiunta di acqua e,
conseguentemente per l’aumento del rapporto a/c, non è più recuperabile.
Quindi, ai fini della collaudabilità poco importa quale sarebbe stata la
resistenza a compressione del calcestruzzo prima di procedere
all’introduzione di acqua in betoniera. Ai fini dell’accertamento delle responsabilità del
produttore, invece, occorre fare un netto distinguo (Figura 1):
dove H2O è il quantitativo di
acqua per m3 aggiunto in betoniera. In accordo con l’equazione [10] la perdita di resistenza
derivante dalle riaggiunte è stimabile all’incirca in un 7% per ogni 10 kg/m3
di acqua introdotti nella botte. Se, ad esempio, al momento del getto il
calcestruzzo possedeva una lavorabilità S2 conforme a quella pattuita e
l’impresa ha richiesto un aggiunta di acqua di 22 kg/m3 per
portare il calcestruzzo in classe di consistenza S4 e, successivamente, dalle
prove di schiacciamento la resistenza a compressione della carota estratta
dalla struttura ha evidenziato un valore di 27 N/mm2, per il calcolo
della resistenza a compressione equivalente si effettuerà la seguente
correzione:
Quest’ultimo valore rappresenta la resistenza a
compressione del calcestruzzo prima della riaggiunta di acqua richiesta
dall’impresa.
Figura 1 – Le riaggiunte di acqua in autobetoniera ai
fini della collaudabilità delle strutture e dell’accertamento delle responsabilità
del produttore di calcestruzzo La compattazione del calcestruzzo delle strutture in opera
Il controllo di accettazione del calcestruzzo, come ben
noto, viene effettuato su provini compattati a “rifiuto” contraddistinti
dall’assenza di aria in eccesso rispetto a quella “fisiologica” e, pertanto,
connotati dalla massima massa volumica. L’estrazione delle carote, invece,
avviene da strutture in opera che la cui massa volumica dipende strettamente
dalle modalità di effettuazione e dalla durata della vibrazione. Pertanto, se
la compattazione dei getti non viene effettuata correttamente, la massa
volumica del calcestruzzo in opera può risultare anche sensibilmente
inferiore a quella del cubetto compattato a rifiuto per via di una maggiore
percentuale di aria residua rispetto a quella fisiologica. Il maggior volume
di aria residua si rende responsabile di una diminuzione della resistenza a
compressione del calcestruzzo in opera rispetto a quella che lo stesso
conglomerato avrebbe attinto qualora fosse stato compattato a rifiuto come il
cubetto destinato ai controlli di accettazione a bocca di betoniera.
Purtroppo, il deficit di resistenza meccanica a compressione non è più
recuperabile e, pertanto, è poco importante dal punto di vista della collaudabilità
sapere che un determinato calcestruzzo avrebbe posseduto una resistenza a
compressione maggiore di quella determinata sperimentalmente sulla carota se
l’opera fosse stata sottoposta ad una compattazione efficace quanto quella
del cubetto. Per questo motivo, la resistenza misurata sulle carote non deve
essere corretta per tener conto dell’inefficacia della compattazione. Questo
equivale a dire che il coefficiente correttivo che tiene conto delle
operazioni di compattazione, FCom,
ai fini della collaudabilità deve essere posto pari ad 1 e per questo motivo,
sostanzialmente, non appare nell’equazione [3] per il calcolo della
resistenza cubica in opera (Rc-opera). Ai fini della valutazione
della resistenza cubica a compressione potenziale, invece, è necessario
quantificare la diminuzione della resistenza per effetto di una inadeguata
compattazione effettuata dall’impresa esecutrice. In sostanza, quindi, si
pone il problema di valutare quale sarebbe stato il valore della resistenza a
compressione se il calcestruzzo in opera fosse stato compattato a rifiuto
alla stregua dei provini per il controllo di accettazione. A tale scopo si
ammette che la perdita di resistenza è all’incirca il 7.5% per ogni 1% di
diminuzione della massa volumica rispetto al valore massimo atteso
(corrispondente a quella del cubetto compattato a rifiuto). In accordo con
questo assunto, il fattore di correzione FCom per il quale
moltiplicare il valore sperimentale della resistenza a compressione
determinato sulla carota vale:
dove: - mvcar è la massa
volumica del calcestruzzo della carota in kg/m3; - mvcub è la massa
volumica del cubetto prelevato a bocca di betoniera in kg/m3. Pertanto, se la resistenza a
compressione misurata su una carota estratta dalla struttura in opera è
risultata pari a 32 N/mm2 e la sua massa volumica di 2.250 kg/m3
contro quella misurata sul cubetto di 2.310 kg/m3, la resistenza
cubica a compressione potenziale (cioè quella che avrebbe posseduto la carota
se sottoposta ad una compattazione efficace quanto quella del cubetto)
sarebbe pari a:
Il calcolo della resistenza cubica potenziale, che in
accordo all’esempio precedente sembrerebbe alquanto semplice, presenta non
pochi problemi dal punto di vista pratico in quanto se fossero disponibili le
masse volumiche dei cubetti prelevati a bocca di betoniera sarebbero anche
disponibili i dati di resistenza meccanica a compressione e, quindi, sarebbe
non necessario, per stabilire eventuali responsabilità del fornitore,
effettuare alcuna valutazione dei dati di resistenza a compressione relativi
alle carote in quanto quelli sui prelievi sarebbero più che sufficienti. In
assenza, invece, dei dati relativi ai cubetti, in quanto di questo si sta
disquisendo, non sarebbero disponibili le masse volumiche del calcestruzzo
compattato a rifiuto. Si potrebbe ovviare a questo inconveniente richiedendo
al produttore i dati di massa volumica del calcestruzzo indurito determinati
nell’ambito delle normali procedure che egli attua durante il controllo di
produzione. Relativamente a quest’aspetto occorre sottolineare che la massa
volumica dei cubetti compattati a rifiuto, al pari della resistenza meccanica
a compressione, è contraddistinta da una dispersione di risultati (Tabella 7) derivante dal fatto che, durante il campionamento, per
via del diverso volume di aggregato grosso tra un cubetto e l’altro, la massa
volumica può risultare differente. Pertanto, se si analizza il singolo dato
di massa volumica non è detto che ad un minor valore corrisponda una minore
resistenza. Ad esempio, in Tabella
7, che si riferisce
alle misure di massa volumica e di resistenza a compressione a 28 giorni di
cubetti prelevati da uno stesso conglomerato prodotto in giornate distinte e
compattati a rifiuto, si rileva come i prelievi n.7 e 8 che posseggono masse
volumiche sostanzialmente coincidenti evidenziano resistenze a compressione
diverse o, il che è lo stesso, come il prelievo 1, pur possedendo una massa
volumica di 2.468 kg/m3 molto più alta di quella (2.367 kg/m3) del prelievo 7,
possegga resistenza a compressione di 40 N/mm2 minore di quella
(43 N/mm2) del prelievo (n.7) con la massa volumica più bassa.
Questo induce a ritenere che nell’equazione [11] per la stima
dell’abbattimento della resistenza derivante da incompleta compattazione per
la massa volumica del calcestruzzo compattato a rifiuto si dovrà far
riferimento al valore caratteristico della massa volumica desunto dai
controlli di produzione (mvkcub-produzione).
Tabella 7 – Massa volumica e resistenza a compressione a
28 giorni di cubetti prelevati da uno stesso conglomerato prodotto in
giornate distinte e compattati a rifiuto La variabilità dei valori di massa volumica derivanti
dal campionamento si riflette evidentemente anche sulle carote estratte dalle
strutture. Pertanto, se si analizza una carota singola non è detto che ad un
minor valore della massa volumica della carota corrisponda necessariamente un
valore più basso della resistenza (Tabella 8). Ad esempio, in Tabella 8 si può notare come la carota 2 di massa volumica
(2.252 kg/m3) inferiore a quella (2.317 kg/m3) della
carota 9 presenta un valore della resistenza a compressione sostanzialmente
identico a quello evidenziato da quest’ultima (19,8 e 20,0 N/mm2,
rispettivamente). Mentre, le carote 9 e 10 che hanno masse volumiche
sostanzialmente coincidenti (2.317 e 2.329 kg/m3) presentano
resistenze meccaniche significativamente diverse (20,0 e 26,8 N/mm2,
rispettivamente). Alla luce di queste oscillazioni dei valori di massa
volumica è evidente come abbia poco senso (per non dire che può risultare
erroneo) effettuare la correzione al valore sperimentale della resistenza
misurata sulla singola carota - per tener conto dell’influenza della
compattazione - confrontando la massa volumica di ogni carota estratta con quella
del calcestruzzo compattato a rifiuto. In definitiva, quindi, per il calcolo
della resistenza cubica potenziale ai fini dell’accertamento delle
responsabilità del produttore, relativamente all’influenza della
compattazione è opportuno far riferimento al valore caratteristico della
massa volumica dell’intero lotto di carote prelevato (mvkcarote-lotto). Questo valore verrà confrontato con
quello caratteristico dei cubetti compattati a rifiuto desunto dai dati di produzione
del calcestruzzo. In accordo con quanto affermato, il coefficiente di
correzione riferito all’intero lotto di carote, FCom-lotto, verrà determinato in accordo alla
seguente equazione:
Alla luce di quanto sopra riportato è evidente che
quando si intende accertare la responsabilità del produttore attraverso il
calcolo della resistenza cubica equivalente occorre sottoporre a prova un
lotto di carote che sia rappresentativo, in termini di massa volumica del
conglomerato, delle strutture che si stanno indagando. Questo significa che
il numero di carote minimo da utilizzare deve essere anche per volumi di
calcestruzzo inferiori a 50 m3 almeno pari a 7. Questo lotto
minimo verrà incrementato di 3 carote per ogni ulteriori 50 m3 di
conglomerato gettato.
Tabella 8 – Massa volumica e resistenza a compressione di
carote prelevate da una struttura realizzata con calcestruzzo di stessa Rck
nominale Le modalità e la durata della maturazione umida delle strutture
I provini confezionati a bocca di betoniera per il
controllo di accettazione del calcestruzzo vengono maturati in ambiente con
U.R. del 95% al fine di favorire una corretta idratazione del cemento e,
conseguentemente, lo sviluppo delle resistenze meccaniche a compressione nel
tempo. Il calcestruzzo in opera, salvo che nelle strutture idrauliche o
permanentemente immerse, viene maturato a umido per tempi molto più brevi,
sovente anche per sole 24 ore. La minore durata della maturazione umida
determina per il calcestruzzo in opera un minor grado di idratazione e,
conseguentemente, un minor valore della resistenza a compressione rispetto a
quello che lo stesso conglomerato avrebbe attinto qualora fosse stato
mantenuto in ambiente umido per 28 giorni. É da far notare, tuttavia, come
l’assenza di maturazione umida determina una diminuzione della resistenza
meccanica a compressione soltanto nei primi 2,5 ÷ 3 cm di calcestruzzo più
corticale. Pertanto, se si vuole eliminare l’influenza della mancata
maturazione umida sul valore della resistenza a compressione della carota
estratta dalla struttura basta rimuovere, mediante taglio meccanico, i primi
3 cm di calcestruzzo corticale. Questa operazione è possibile anche per le
strutture di spessore inferiore a 120 mm esposte da entrambi i lati
all’atmosfera asciutta dove l’asportazione di 30 mm di calcestruzzo su
entrambi i fronti della parete determinerebbe per le carote un’altezza di
50÷60 mm, ancora sufficiente per poter effettuare la prova di schiacciamento
per determinare la resistenza a compressione. Pertanto, relativamente alla maturazione umida dei getti si può concludere che
ai fini dell’accertamento delle responsabilità del produttore rimuovendo 2,5
÷ 3 cm del calcestruzzo corticale non si rende necessario apportare alcuna
correzione al valore sperimentale della resistenza a compressione misurata
sulle carote estratte dalla struttura. Calcolo
della resistenza cubica potenziale ai fini dell’accertamento delle
responsabilità del produttore
In definitiva, riassumendo tutte le considerazioni
contenute ai precedenti paragrafi si può suggerire il metodo per il calcolo della resistenza cubica
potenziale ai fini dell’accertamento delle responsabilità del fornitore del
calcestruzzo. Esso consiste di due stadi distinti descritti nel seguito. · PRIMO STADIO Il primo stadio del metodo suggerito è finalizzato alla
trasformazione del valore sperimentale della resistenza a compressione di
ogni singola carota in quello potenziale escludendo in questa prima fase di quantificare
l’effetto derivante da una incompleta compattazione:
dove:
· SECONDO STADIO Calcolati i singoli valori della resistenza cubica
equivalente derivanti da quelli sperimentali ottenuti sulle carote estratte
dalla struttura si procederà a calcolare:
Noti i valori di Rcm-potenziale-lotto,
di Rcmin-potenziale-lotto,
del tipo di controllo di accettazione (A o B (5))
fissato dal capitolato e della resistenza caratteristica a compressione di
progetto (Rckprogetto) pattuita contrattualmente tra fornitore e
impresa si potrà verificare se sono soddisfatte o meno le disequazioni
previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni. A chiarimento del metodo
proposto si riporta nel paragrafo che segue un esempio pratico. Esempio di calcolo della resistenza cubica in equivalente
ai fini dell’accertamento delle responsabilità del produttore
Si supponga di aver effettuato una campagna consistita
in 15 carotaggi (diametro 100 mm) da una pavimentazione in calcestruzzo, di
spessore pari a 20 cm armata con una rete elettrosaldata poggiata sulla
massicciata, realizzata durante il periodo invernale da 60 giorni circa.
Durante questo periodo la temperatura media ponderale esistente in cantiere è
stata di 15°C. Le carote sono state sottoposte dapprima ad un taglio
meccanico per la rimozione di circa 5 cm di calcestruzzo da entrambi i lati
e, successivamente, a rettifica e spianatura fino ad ottenere un’altezza di
100 mm. I risultati sperimentali di resistenza meccanica a compressione e
massa volumica ottenuti per le singole carote sono riportati in Tabella 9. A completamento delle informazioni disponibili dai
documenti di trasporto emerge che al momento dell’esecuzione del getto
l’impresa ha richiesto un’aggiunta di acqua in betoniera di 15 kg/m3.
Durante l’esecuzione dei lavori, inoltre, sono stati omessi gli obbligatori
prelievi per il confezionamento dei cubetti destinati al “controllo di
accettazione” di tipo A per verificare se il calcestruzzo fornito fosse o
meno conforme al valore caratteristico di progetto (Rckprogetto) e
pattuito contrattualmente tra impresa e fornitore pari a 35 N/mm2.
Dal dossier fornito dal produttore, infine, emerge che il calcestruzzo è
stato confezionato con cemento CEM II/A-LL 42.5R e che il valore
caratteristico della massa volumica caratteristica del calcestruzzo
compattato a rifiuto desunto dai dati di produzione (mvkcub-produzione)
è pari a 2.303 Kg/m3. Stabilire in base ai valori di resistenza a
compressione ottenuti sulle carote se esistono responsabilità da parte del
produttore del conglomerato, cioè se il calcestruzzo fornito possedeva
resistenza caratteristica inferiore a quella pattuita contrattualmente. Verifichiamo dapprima se la struttura è collaudabile o
meno utilizzando la formula precedentemente menzionata:
snellezza: h/d=1 , Fh/d
vale 1.0 (Tabella
2); ferri assenti: FFe =1.0 (equazione [1]); tormento: considerato sulla media dei valori FTor
= 1.10 (Tabella 3); direzione carotaggio
parallela a quella di getto: FDir = 1.00 (Tabella 4); età della carota 60
giorni e cemento di classe 42.5R: Ft
= 1.00; temperatura di
maturazione in cantiere 15°C e 60 giorni: FT = 1.00. Quindi, si può procedere al calcolo di Rc-opera:
I valori ottenuti per Rc-opera sono riportati in Tabella 9. Si può procedere, quindi, al calcolo dello scarto
quadratico medio dei valori di Rc-opera il quale risulta pari a
2.2 N/mm2 e successivamente alla stima della resistenza
caratteristica cubica in opera Rck-opera in accordo con la EN
13791: Rck-opera = 25.7 – 1.48 · 2.2= 22.4N/mm2 Rck-opera = 22.88 + 4 = 26.9 N/mm2 Pertanto, il valore caratteristico della resistenza
cubica in opera vale 22.4 N/mm2. Questo valore caratteristico non soddisfa il criterio
di collaudabilità stabilito dalla EN 13791, in quanto: Rck-opera = 22.4 N/mm2 < 29.75
N/mm2 = 0.85 * 35 = 0.85 * Rck-progetto Ne consegue che la
struttura non è collaudabile in accordo alla EN 13791. In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.
14.01.2008): Rcm-opera = 25.7 N/mm2 < 37.9
N/mm2 = 0.85 × 44.6 = 0.85 · (35 + 9,6) = 0.85 · Rcm-progetto Quindi, la
struttura non è collaudabile in accordo al D.M. 14.01.2008. Si pone, pertanto, il problema di stabilire se la non
collaudabilità della struttura sia da attribuire o meno al fornitore del
calcestruzzo. La prima operazione da fare è quella di calcolare la resistenza
cubica potenziale di ogni singola carota (Rcpotenziale-i), senza
tener conto dell’influenza sui dati di resistenza a compressione
dell’eventuale inaccuratezza nella compattazione dei getti, utilizzando
l’equazione [13]:
snellezza: h/d=1 , Fh/d vale 1.0 (Tabella 2); ferri assenti: FFe =1.0 (equazione [1]); tormento: considerato sulla media dei valori FTor
= 1.10 (Tabella
3); direzione carotaggio
parallela a quella di getto: FDir = 1.00 (Tabella 4); età della carota 60
giorni e cemento di classe 42.5R: Ft
= 0.94 (Equazione [2]); temperatura di
maturazione in cantiere 15°C e 60 giorni: FT = 0.95 (Tabella 5); aggiunta di acqua in
betoniera richiesta dall’impresa 15 kg/m3: FH2O =
1.12 (Equazione [10]) Si può procedere quindi al
calcolo di:
Come si può notare, nel caso in esame la resistenza
cubica potenziale (al netto dell’effetto dovuto alla compattazione) è
sostanzialmente coincidente con il valore della resistenza cubica in opera in
quanto l’incremento di resistenza da apportare per tener conto delle
riaggiunte di acqua richieste dall’impresa è compensato dal fatto che le
prove di schiacciamento avvengono su carote maturate a temperature più basse
di 20°C e con un età (60 giorni) maggiore della stagionatura (28 giorni) alla
quale sarebbe dovuti essere sottoposti a prova i cubetti. I valori ottenuti
per Rcpotenziale-i sono riportati in Tabella 9. In base alle masse volumiche misurate per i singoli
carotaggi si determina il valore caratteristico di questa grandezza relativo
all’intero lotto sottoposto a prova (mvkcarote-lotto)
pari nel caso in esame a 2263 kg/m3. A questo punto si può
calcolare il coefficiente correttivo che tiene conto delle modalità di
compattazione riferito all’intero lotto di carote sottoposte ad indagine
tenendo conto della massa volumica del calcestruzzo compattato a rifiuto
(2.303 kg/m3) desunta dai dati di produzione.
Si può, a questo
punto, calcolare il valore medio e quello minimo della resistenza cubica
equivalente dell’intero lotto e che tengono conto anche dell’influenza della
compattazione: Rcm-potenziale-lotto = 25,68 · 1,18 = 30.32
N/mm2 Rcmin-potenziale-lotto = 22,88 · 1,18 = 27
N/mm2
Tabella 9 – Valori sperimentali della resistenza a
compressione misurata sulle carote, resistenza a compressione potenziale Rcpotenziale-i
e massa volumica dei singoli carotaggi Per l’opera era stato previsto un controllo di
accettazione di tipo A e la resistenza caratteristica a compressione di
progetto (oltre che pattuita contrattualmente) era di 35 N/mm2. Ai
fini dell’accertamento delle responsabilità del fornitore è necessario
verificare le seguenti disuguaglianze: Rcmpotenziale-lotto = 30,32 N/mm2
< 35 + 3,5 N/mm2 Rcminpotenziale-lotto =
27,0 N/mm2 < 35 – 3,5 N/mm2 Entrambe le disuguaglianze non sono verificate.
Pertanto, si può concludere che il
calcestruzzo fornito possedeva resistenza caratteristica a compressione,
qualora la stessa fosse stata determinata sui cubetti confezionati e
stagionati in accordo alle norme di legge sui controlli di accettazione, non
conforme a quella prevista in progetto e contrattualmente pattuita. La
resistenza caratteristica del calcestruzzo fornito, infatti, si attesta a
circa 27 N/mm2 inferiore, quindi, al valore (35 N/mm2)
di progetto. Tenendo presente che il valore caratteristico della
resistenza cubica in opera è pari a 22.4 N/mm2 e risulta inferiore
dell’85% del valore caratteristico della resistenza cubica potenziale (23 =
0.85 × 27) si può anche concludere che la non collaudabilità
della struttura ricade sotto la responsabilità
sia del fornitore di conglomerato che dell’impresa esecutrice. NOTE
Bibliografia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ingegneriastrutturale.net -
Tutti i Diritti Riservati |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||